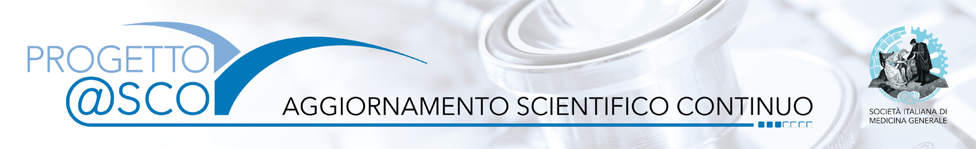Critical Appraisal Dossier sull’utilizzo delle statine |  |
E’ stata analizzata la letteratura metanalitica sperimentale 2005-2007 sullimpiego di statine nella prevenzione di eventi cardiovascolari allo scopo di:
- quantificare la loro efficacia clinica
- identificare le molecole e/o le dosi più efficaci
- identificare la relazione esistente tra le variazioni della colesterolemia LDL e lincidenza di eventi cardiovascolari.
Sono stati recuperati tutti gli RCT recensiti da due importanti revisioni sistematiche della letteratura e da altre due metanalisi reperite in MedLine attraverso una ricerca autonoma. E’ stata valutata la qualità metodologica di tutte le revisioni esaminate. Sono stati considerati solo gli studi riguardanti lincidenza di outcome maggiori (incidenza di eventi CVD come infarto non fatale + morte CHD; stroke; morte CHD;morte da tutte le cause) in cui le statine fossero confrontate
- vs placebo
- vs altre statine
- verso dosi diverse di statine.
Sono stati analizzati 30 confronti statine vs placebo, due confronti statine vs statine e un confronto tra dosi diverse della stessa statina. Nei confronti vs placebo e nei pazienti ad alto rischio coronarico (AR>20% in dieci anni) le statine si sono dimostrate utili nella prevenzione di tutti e quattro gli outcome considerati; nei pazienti con profilo di rischio inferiore si sono dimostrate utili nella prevenzione dei due outcome coronarici. Dai confronti vs placebo non è stato possibile quantificare i vantaggi legati ad interventi più aggressivi in termini di abbattimento di [LDL-CL] in quanto la relazione tra variazioni della colesterolemia ed incidenza di eventi dimostrata da studi osservazionali non è stata sufficientemente chiarita dalle evidenze sperimentali. I confronti testa a testa e i confronti tra diverse dosi di statina hanno dimostrato che la somministrazione di atorvastatina ad alto dosaggio offre vantaggi nei pazienti affetti da sindromi coronariche acute e da CHD stabilizzata nellincidenza di alcuni outcome CVD. Le evidenze sperimentali non hanno quantificato in modo preciso la relazione tra variazioni della colesterolemia LDL e lincidenza di eventi cardiovascolari.
Scopi del documento
Scopo di questo capitolo è analizzare la principale recente letteratura metanalitica sullutilizzo di statine nella prevenzione dellincidenza di eventi cardiovascolari, limitatamente alle evidenze sperimentali. Definiamo evidenze sperimentali, quelle derivanti da studi Randomizzati e Controllati.
La ricerca bibliografica si è proposta di affrontare questi quesiti
- Qual è l’efficacia clinica delle statine nella prevenzione di eventi cardiovascolari?
- Quale molecola e/o quale dosaggio è in grado di prevenire più efficacemente gli eventi cardiovascolari?
- La relazione tra abbassamento della colesterolemia LDL e variazione del rischio cardiovascolare messa in luce da studi osservazionali è dimostrata in modo univoco anche da evidenze sperimentali?
Sono stati esclusi trial su lombalgia associata a traumi maggiori, cancro, infezioni, sindrome della cauda equina, fibromialgia, osteoporosi e fratture vertebrali.
Quesito 1: Qual è lefficacia clinica delle statine nella prevenzione di eventi cardiovascolari?
I confronti statine vs placebo
I confronti verso placebo rappresentano il modello migliore per studiare il guadagno netto di un intervento farmacologico in termini di efficacia. Abbiamo pertanto indirizzato la nostra ricerca in tal senso con la finalità di teorizzare modelli di intervento patient based in gestioni integrali del rischio cardiovascolare individuale.
Abbiamo utilizzato come fonte primaria di evidenza gli Studi Randomizzati e Controllati reclutati da due vaste revisioni sistematiche pubblicate negli ultimi tre anni (Oregon 2005 [14] e NICE 2006 [38]). Abbiamo quindi cercato di integrare queste due fonti ricercando in MedLine altre metanalisi pubblicate tra il 2005 e il 2007.
Strategia della ricerca bibliografica
La query utilizzata nella nostra strategia di ricerca ha considerato i seguenti elementi (tabella 1): a. Partecipanti: pazienti di entrambi i sessi già affetti o non affetti da precedenti cardiovascolari b. Interventi: confronti statine vs placebo c. Outcome: infarto miocardico o stroke fatali o non fatali. Outcome secondari: mortalità coronarica e mortalità generale. d. Publication type: metanalisi pubblicate tra il 2005 e il 2007 da cui recuperare RCT (evidenze sperimentali) riguardanti confronti statine vs placebo.
Obbedivano ai nostri criteri dinclusione RCT con durata superiore a 26 settimane, periodo minimo considerato necessario alla raccolta di eventi nei confronti statine vs placebo [38].
A parte abbiamo anche valutato i pochi studi recensiti dalle metanalisi caratterizzati da confronti test a testa tra statine diverse o da confronti di dosi diverse della stessa statina, limitatamente ai trial dove loutcome primario era rappresentato da eventi cardiovascolari.
Risultati della ricerca bibliografica
La nostra ricerca ha prodotto quattro referenze [60, 64, 65, 66]. Abbiamo escluso la referenza [66] in quanto non si trattava di una revisione sistematica della letteratura:gli autori nella loro metanalisi avevano infatti sottoposto a pooling tre trial selezionati arbitrariamente. Abbiamo escluso dalla nostra revisione i trial recensiti dalla metanalisi [65] in quanto caratterizzati da follow-up non più lunghi di 24 settimane. Per lo stesso motivo abbiamo escluso anche alcuni studi inclusi nella metanalisi Oregon [14] perchè - relativamente ai confronti statine vs placebo - altrettanto caratterizzati da follow-up di durata inferiore alle 26 settimane: si tratta degli RCT: A to Z trial[49], PACT[50], MIRACL[51], Den Hartog[52].
Cinque studi recuperati dalle metanalisi (ALLIANCE[34], GREACE[35], ESTABLISH[36], L-CAD[48], ALLHAT-LLT[9]) avevano utilizzato come comparatore le terapie abitualmente somministrate ai pazienti dislipidemici (’usual care). I primi quattro reclutavano pazienti coronaropatici, lultimo ha reclutato pazienti generalmente dislipidemici. La metanalisi[64] ha considerato anche lo studio GISSI Prevention [63], che abbiamo escluso per lo stesso motivo.
Abbiamo pertanto considerato per la nostra revisione solo gli studi caratterizzati da confronti vs placebo (tabella 2 e tabella 3). I motivi di questa scelta risiedono nel fatto che i confronti statine verso terapie abituali forniscono risultati molto difficili da interpretare e da generalizzare: il range di trattamenti offerti al gruppo di controllo è, infatti, molto ampio e il concetto di ‘usual care può variare grandemente tra un setting e laltro [38].
A parte abbiamo anche valutato i pochi studi recensiti dalle metanalisi caratterizzati da confronti test a testa tra statine diverse o da confronti di dosi diverse della stessa statina, limitatamente ai trial dove loutcome primario era rappresentato da eventi cardiovascolari.
Classificazione degli studi recensiti
Nella tabella 3 i trial vengono classificati in quattro gruppi a seconda dei criteri di inclusione utilizzati nelle singole ricerche [38]. Lo strato A della tabella 3 comprende trial che hanno arruolato soggetti privi di qualsiasi danno cardiovascolare in condizioni di base (prevenzione primaria cardiovascolare). Lo strato B della tabella 1 comprende trial che hanno arruolato soggetti privi di coronaropatia al momento dellarruolamento ma non necessariamente esenti da vasculopatie non coronariche (prevenzione primaria coronarica). Parte dei soggetti arruolati in queste ricerche, anche se esente da danni coronarici, era però caratterizzata dalla presenza di danni vascolari di altro tipo. Una frazione della casistica arruolata dai trial inclusi in questo sottogruppo poteva quindi essere inquadrata nel gruppo D (vedi oltre). Lo strato C della tabella 3 comprende soggetti che al momento dellarruolamento avevano già subito un danno coronarico (prevenzione secondaria coronarica). Lo strato D della tabella 1 comprende soggetti che al momento dellarruolamento avevano già subito una qualsiasi forma di danno vascolare (prevenzione secondaria cardiovascolare). Lo strato E della tabella 2 è caratterizzato dai trial che hanno arruolato pazienti con danni cardiovascolari al momento dellarruolamento accanto a pazienti privi di danni cardiovascolari al momento dellarruolamento (Casistiche miste).
Ricerca di Publication bias
Abbiamo valutato la presenza di publication bias attraverso lanalisi al Funnel Plot[54]. I grafici riferiti ai singoli end-point restituiscono curve abbastanza simmetriche, a favore dellassenza di publication bias (Grafico 2, 4, 6).
Prevenzione primaria o secondaria?
A nostro parere la stratificazione degli studi in base alle definizioni classiche di interventi di prevenzione primaria o secondaria (riportate anche dagli autori NICE[38] e illustrate nella tabella 1) dovrebbe essere probabilmente superata. Tra laver subito un evento cardiovascolare e lassoluta assenza di danno cardiovascolare esiste, infatti, un gradiente di rischio rappresentato da infinite situazioni intermedie molto mal definite dalla definizione dicotomica di solito utilizzata. Infatti, un paziente con anamnesi negativa per eventi cardiovascolari ma affetto da grave arteriopatia ostruttiva e quindi ad altissimo rischio potrebbe essere arruolato in uno studio di prevenzione primaria assieme a soggetti altrettanto privi di eventi cardiovascolari ma con albero arterioso al contrario indenne, contribuendo a peggiorare in modo anomalo la prognosi complessiva della coorte. Per esempio lo studio CAIUS[21], incluso negli studi di prevenzione CVD primaria, ha arruolato solo pazienti affetti da danno aterosclerotico. In seconda istanza, il diabete mellito è ormai considerato un ’equivalente vascolare perchè la prognosi cardiovascolare dei pazienti diabetici è simile a quella di chi ha già subito un danno. Ciononostante le metanalisi che hanno affrontato il ruolo delle statine nella prevenzione cardiovascolare primaria hanno incluso costantemente lo studio CARDS[12] (che ha arruolato solo pazienti diabetici) entro gli interventi di prevenzione primaria [38, 60]. Complicano ancora di più il problema, gli studi classificati al punto E della tabella 1, vale a dire i trial che hanno reclutato casistiche miste. La stratificazione di queste ricerche in studi di prevenzione primaria o secondaria’ dipende così solo da criteri soggettivi. Per esempio Thavendiranathan in una recente metanalisi sul ruolo delle statine in prevenzione primaria definisce in prevenzione primaria gli studi in cui almeno l80% dei partecipanti era privo di precedenti cardiovascolari al momento dellarruolamento [60].
Stratificazione dei trial in base alle caratteristiche basali dei pazienti arruolati
Una stratificazione degli studi in cui le statine sono state confrontate vs placebo in base alla prevalenza basale di diabete o di danno CVD al momento dellarruolamento può essere molto utile per confrontare tra loro le casistiche arruolate nei diversi trial (tabella 4 e tabella 5).
Stratificazione dei trial in base ai rischi basali degli eventi
Appare altrettanto utile stratificare i trial in base al rischio basale dei singoli outcome (tabella 6-7-8-9). Si osserva come la maggior parte dei confronti statine vs placebo sia stata organizzata arruolando soggetti a rischio cardiovascolare medio-elevato. Per esempio considerando loutcome infarto fatale e non fatale, fatta eccezione per gli studi AFCAPS[1] e CAIUS[21] tutte le casistiche erano caratterizzate da un rischio basale maggiore di quello che caratterizza i pazienti ULSS 20 del Veneto (rischio CHD mediano a 10 anni =6,9%, dati non pubblicati).
Appare evidente dalla tabella 6-7-8-9-10, che la classica stratificazione dei trial per “interventi di prevenzione primaria” e “secondaria” non sembra avere molto senso ai fini della trasferibilità dei dati delle singole ricerche in quanto il rischio basale di eventi cardiovascolari è molto eterogeneo allinterno di ciascun sottogruppo. Per esempio nel gruppo A) prevenzione primaria cardiovascolare della tabella 3 (= “non eventi pregressi al baseline”) la mortalità calcolata a 10 anni per lo studio CARDS[12] è pari al 14.5%, contro il 4.5% dello studio AFCAPS[1].
Ammettendo che la ricerca sistematica sia stata sufficientemente esaustiva, ossia che non esistano in letteratura altri confronti statine vs placebo, appare logico estrapolare le conclusioni dei singoli trial, indipendentemente dai criteri di arruolamento utilizzati, a popolazioni caratterizzate da simile profilo di rischio CVD a 10 anni.
Stratificazione dei trial in base ai parametri lipidemici
La tabella 11 identifica i livelli basali di LDL CL in ciascun trial. Eccetto per CARDS[12] e SCAT[13] i livelli basali erano > 130 mg/dl, limite considerato sufficiente dalle linee guida ATP III [72] per iniziare immediatamente la terapia farmacologica accanto alla terapia dietetica nei pazienti ad alto rischio.
La tabella 12 illustra labbattimento netto assoluto e percentuale delle concentrazioni di LDL-CL ottenuto attraverso limpiego di statine. Il range complessivo è pari a 30 punti percentuali (da 18% a 48% circa).
Metanalisi di tutti i trial
La nostra metanalisi dei risultati di tutti i confronti vs placebo ha prodotto risultati omogenei e significativi a favore delle statine per tutti gli outcome considerati (grafici 5, 6, 7, 8)
Conclusioni relative al quesito 1
In base ai risultati esposti nei grafici 5-6-7-8-9
- Le statine abbassano lincidenza di outcome CHD (infarto miocardico fatale e non fatale) RR=0.73 (0.7-0.77)
- Le statine abbassano lincidenza di stroke RR=0.80 (0.74-0.87)
- Le statine abbassano lincidenza di mortalità da tutte le cause RR=0.86 (0.82-0.90)
- Le statine abbassano lincidenza di mortalità CHD RR=0.77 (0.71-0.82)
Le statine abbassano lincidenza di ogni evento CVD RR=0.79 (0.76-0.82)
Appare importante sottolineare che questi risultati sono risultati omogenei entro tutto il pool (Q test P >0.10). Risulterebbe pertanto superfluo procedere ad analisi per sottogruppi stratificando i trial per caratteristiche potenzialmente in grado di costituire elementi di eterogeneità (qualità delle ricerche, livello di rischio basale, livello di colesterolemia LDL basale, livello di abbattimento della colesterolemia LDL, eccetera).
Nonostante queste considerazioni abbiamo comunque ripetuto la metanalisi stratificando i trial per i livelli di rischio basale perchè i dati della letteratura appaiono discordanti circa la natura della relazione esistente tra livelli basali di rischio ed efficacia degli interventi (vedi oltre).
Abbiamo anche eseguito unanalisi di metaregressione (vedi oltre) per valutare la natura della relazione tra efficacia clinica e livelli di colesterolemia LDL basale da un lato e tra efficacia clinica e abbattimento della colesterolemia LDL dallaltro. Infatti, anche su questo argomento i dati della letteratura risultano discordanti.
Metanalisi dei trial caratterizzati da un rischio basale di infarto fatale e non fatale < 20% a 10 anni
Abbiamo stratificato i trial che riportavano loutcome infarto miocardico fatale +morte coronarica in base al rischio basale a 10 anni per questo endpoint. Il rischio di eventi coronarici a 10 anni rappresenta una buona approssimazione del rischio cardiovascolare complessivo: per esempio un rischio CHD pari a 20% in dieci anni corrisponde a un rischio CVD pari al 30% in dieci anni [61] Per lo strato di rischio [<20% a dieci anni] i confronti statine vs placebo dimostrano risultati eccellenti per le statine sullincidenza di infarto miocardico e di eventi coronarici fatali. Per lincidenza di stroke non è emersa differenza significativa rispetto al placebo. Per la mortalità generale, il risultato è a favore delle statine ma con debole significatività statistica.
Metanalisi dei trial caratterizzati da un rischio basale di infarto fatale e non fatale >20% a 10 anni
Per lo strato di rischio [>20% a dieci anni] i risultati sono a favore delle statine per tutti e quattro gli outcome. Esiste peraltro una debole eterogeneità entro il pool relativamente alloutcome mortalità generale.
Metaregressione dei risultati
Attraverso un modello univariato di metaregressione abbiamo rilevato associazioni statisticamente significative tra riduzione dellOdds di morte CHD e valori dei livelli basali di LDL-CL da un lato (P = 0.006) e valori assoluti dellabbattimento di questi livelli dall’ altro (P = 0.017). Le due covariate non risultavano reciprocamente correlate (r = 0.37 P = 0.08). Tuttavia la significatività statistica non era più apprezzabile in un secondo modello di regressione in cui le due covariate venivano aggiustate una rispetto allaltra e in altri modelli che prevedevano linserimento di altre covariate (età, lunghezza del follow-up, rischio basale dellevento). Un ulteriore modello univariato di metaregressione ha dimostrato una associazione inversa tra riduzione dell’ Odds di morte ed età (P = 0.036). Anche in questo caso la significatività statistica veniva però persa aggiustando per le altre covariate.
Conclusioni relative al quesito 1. Riteniamo interessante sottolineare la relazione tra rischio coronarico basale ed efficacia delle statine sullincidenza di outcome cardiovascolari.
A fini pratici abbiamo differenziato lefficacia delle statine in due classi di rischio basale coronarico: pazienti con rischio elevato [>20% in dieci anni] e pazienti a rischio meno elevato [<20% in dieci anni] In conformità a quanto risulta dalle metanalisi (grafici 9-10-11-12-13-14-15-16):
- le statine riducono significativamente lincidenza di outcome coronarici (infarto miocardico fatale e morte CHD) nei pazienti caratterizzati da profilo di rischio elevato [>20% in dieci anni] e anche nei pazienti a profilo di rischio inferiore.
- Le statine riducono significativamente lincidenza di stroke nei pazienti caratterizzati da profilo di rischio elevato [>20% in dieci anni].
- le statine riducono significativamente la mortalità coronarica nei pazienti caratterizzati da profilo di rischio elevato [>20% in dieci anni] e anche nei pazienti a profilo di rischio inferiore.
- Le statine riducono significativamente la mortalità generale nei pazienti caratterizzati da profilo elevato di rischio [>20% in dieci anni].
Quesito 2: Quale molecola e/o quale dosaggio sono in grado di prevenire più efficacemente gli eventi cardiovascolari?
La metanalisi [38] ha identificato tre confronti testa a testa. Nello studio di prevenzione secondaria PROVE-IT Cannon &c [75] ha confrontato in pazienti ospedalizzati per sindrome coronarica acuta lefficacia di due regimi ipolipidemizzanti (atorvastatina 80 mg verso Pravastatina 40 mg) sullincidenza di un outcome composito CVD (infarto miocardico+reospedalizzazioni per angina instabile+reospedalizzazioni per revascolarizzazioni+mortalità generale). La numerosità campionaria era tarata su unipotesi di non superiorità, che è stata disattesa dai risultati, attestanti superiorità per latorvastatina. Nel gruppo assegnato ad atorvastatina, infatti, in un follow-up medio di 24 mesi lincidenza delloutcome composito è risultata significativamente inferiore (0.224 vs 0.263, RRR = 17%) e allo stesso tempo la concentrazione di LDL-CL è risultata decisamente inferiore (1.60 mmol/l vs 2.46 mmol/l). Il risultato sulloutcome composito è stato però trascinato dalla riduzione dellincidenza dei due outcome riguardanti le reospedalizzazioni. La differenza tra i due bracci in termini di rischio di morte coronarica o di morte da tutte le cause non risultava significativamente diversa. Gli autori - anche se non escludono che il risultato possa essere associato a diverse proprietà intrinseche dei due farmaci a confronto - concludono sull’opportunità di raggiungere nei pazienti ospedalizzati per sindromi coronariche acute, livelli lipidemici decisamente inferiori a quelli generalmente raccomandati dalle linee guida. Nello studio viene però riportato - senza alcun commento - che in unanalisi per sottogruppi i benefici sullincidenza delloutcome primario appaiono correlati ai livelli basali di colesterolemia LDL, risultando assenti nei pazienti con concentrazioni basali > 125 mg/dl (Interaction test P = 0.02). Lo studio TNT [76] ha confrontato unampia casistica di soggetti affetti da CHD stabile randomizzandoli a due dosi diverse di atorvastatina, rispettivamente 80 o 10 mg die in un follow-up medio di 4.9 anni. Nel gruppo dintervento il valore medio di colesterolemia LDL raggiunto fu ovviamente più basso rispetto al gruppo di controllo (2.0 mmol/l vs 2.6 mmol/l). Lincidenza dell’outcome primario (morte coronarica + infarto miocardico + rianimazione dopo arresto cardiaco + stroke) risultò significativamente minore nel gruppo assegnato ad alte dosi di statina (ARi: 0.0.87; ARc 0.109; P<0.01). La differenza tra i due bracci in termini di rischio di morte coronarica o di morte da tutte le cause non risultò significativamente diversa. Lo studio non riporta analisi per sottogruppi. Gli autori concludono sottolineando che i risultati del trial appaiono coerenti con quanto dimostrato da altri analoghi interventi di prevenzione secondaria (4s, LIPID, CARE, HPS, CARE), tutti a sostegno di una proporzionalità tra livelli di colesterolemia LDL e incidenza di eventi cardiovascolari. Questa analisi è solo quantitativa e viene illustrata dalla figura 4 riportata dal trial, dove vengono plottati i rischi assoluti degli eventi CVD (outcome primari?) nel braccio di intervento e rispettivamente nel braccio di controllo dei sei trial. Gli autori raccomandano quindi di raggiungere in prevenzione secondaria livelli target di colesterolemia LDL molto inferiori a quelli usualmente raccomandati. Tuttavia se gli stessi dati sono analizzati formalmente in un modello univariato di metaregressione (osservazione personale) non è possibile dimostrare associazioni statisticamente significative tra variazione percentuale di [LDL-CL] e logOR di outcome primario (P = 0.695 per il coefficiente della covariata). Anche aggiustando per il livello basale di [LDL-CL] i risultati non cambiano. Il terzo studio, REVERSAL [77] ha confrontato lefficacia di 80 mg di atorvastatina vs 40 mg di pravastatina nel rallentare la progressione degli ateromi coronarici (outcome surrogato). Il regime a base di atorvastatina ha garantito livelli medi di colesterolemia LDL più bassi rispetto al trattamento a base di pravastatina (2.05 mmol/l vs 2.85 mmol/l), con riduzione significativa della progressione del volume degli ateromi (P = 0.02).
Conclusioni relative al quesito 2
I risultati dei primi due studi [75, 76] hanno dimostrato che limpiego di alte dosi di atorvastatina in pazienti affetti da sindromi coronariche acute o con danno coronarico stabilizzato è in grado di ridurre linsorgenza di due outcome compositi cardiovascolari.
I risultati sono interessanti, ma in entrambi i casi lintervento non ha dimostrato di ridurre la mortalità generale o la mortalità coronarica (outcome peraltro secondari in entrambe le ricerche). Linterpretazione clinica dei risultati dello studio PROVE-IT [75] è resa difficile dalla scelta dei singleton-end point che costituiscono l’outcome primario, rappresentati parzialmente da outcome clinician-driven (ospedalizzazioni per angina o per interventi di rivascolarizzazione) e quindi potenzialmente condizionabili da decisioni soggettive degli operatori. L’interpretazione dei risultati dello studio TNT [76] è invece complicata dallutilizzo nelloutcome composito primario del singleton end-point stroke, potenzialmente condizionato da meccanismi patogenetici non completamente condivisi con gli altri outcome più propriamente coronarici (sarebbe stata più robusta la scelta di singleton-endpoint caratterizzati da substrati fisiopatologici più condivisi, come lassociazione morte CHD+infarto non fatale+rianimazione). Infine (vedi sopra e oltre) i risultati forniti dai due trial non hanno contribuito a definire in un modello preciso il rapporto tra variazioni di [LDL-CL] e rischio cardiovascolare.
A nostra impressione gli studi attualmente disponibili non consentono una risposta solida a questo quesito.
Quesito 3: La relazione tra abbassamento della colesterolemia LDL e variazione del rischio cardiovascolare messa in luce da studi osservazionali è dimostrata in modo univoco anche da evidenze sperimentali?
Questo quesito appare di fondamentale importanza in quanto qualora esistessero evidenze sperimentali forti a favore dellesistenza di una relazione log-lineare tra abbassamento della colesterolemia e riduzione del rischio risulterebbe assolutamente vantaggioso utilizzare molecole e dosi che consentano riduzioni maggiori di LDL colesterolo rispetto a di molecole e dosi che consentono riduzioni minori.
Modelli statistici teoricamente utilizzabili per studiare lassociazione tra variazioni di [LDL-CL] ed incidenza di outcome clinici
- Analisi per sottogruppi
In unanalisi di sottogruppi stratificati per livelli diversi di [LDL-CL] basale valori di P a favore di significatività statistica allInteraction test potrebbero suggerire risultati defficacia diversi tra uno strato e laltro: in tal caso potrebbe essere sospettato un effetto soglia, vale a dire un livello di [LDL-CL] al di sotto (o al di sopra) del quale lefficacia clinica del trattamento potrebbe risultare diversa. Valori di P non significativi allInteraction test potrebbero sostenere allopposto la non dimostrazione di diversa efficacia tra i vari strati. Queste analisi sono condotte post hoc, e come tali dovrebbero essere considerate con estrema cautela perchè i risultati riscontrati a livello di singoli sottogruppi potrebbero essere solo un effetto del caso. Risulta particolarmente pericoloso, per inflazione di errore di I tipo, considerare con fiducia i risultati significativi registrati nominalmente per ogni confronto. Maggiori informazioni sono fornite dall’Interaction test senza dimenticare peraltro l’intrinseca debolezza informativa di queste analisi. - Modelli di Regressione logistica
Modelli di regressione logistica potrebbero contribuire a dimostrare una proporzionalità misurabile tra rischio dell evento (espresso in termini di log-Odds) , livelli di colesterolemia LDL basale e/o variazioni assolute o percentuali della colesterolemia LDL indotte dalla terapia. La presenza di significatività al test per il coefficiente angolare della covariata [LDL-CL] associata a buoni valori della P prodotta dal Likelihood Ratio test per tutto il modello sarebbero in tal caso a sostegno di questa ipotesi . Ovviamente risulta sempre critica la scelta delle altre covariate, che vincola la fittabilità generale di qualsiasi modello di regressione. - Analisi della sopravvivenza
Il modello a rischi proporzionali di Cox è unanalisi multivariata associata agli studi di sopravvivenza. LHazard Ratio che corrisponde allesponenziale del coefficiente della covariata [LDL-Cl] esprime di quanto varia lhazard rate dellevento per ogni variazione unitaria di [LDL-CL]. Anche in questo caso la covariata può essere rappresentata dai livelli di colesterolemia LDL basale oppure dalle variazioni assolute o percentuali della colesterolemia LDL indotte dalla terapia. In tal caso il valore e il segno del coefficiente angolare di [LDL-CL], se associato a valori di P <0.05 al test di significatività per lo stesso coefficiente, sono a sostegno di associazioni quantificabili tra le due variabili, che vengono espresse da un Hazard Ratio. Ovviamente anche in questo caso è critica la scelta delle altre covariate, che oltre al rispetto dellassunto dei rischi proporzionali - vincola la fittabilità del modello intero ed è necessario che tutto sia associato a buoni valori della P prodotta dal Likelihood ratio test per tutto il modello. - Analisi di Metaregressione
In questo caso il modello di regressione è tarato su una covariata rappresentata da dati aggregati. Vale a dire che lunità di analisi per la variabile indipendente non è rappresentata dai dati sulla colesterolemia LDL-CL misurati a livello del singolo paziente ma piuttosto dai dati sulla colesterolemia LDL-CL rilevati per tutto il trial. Le analisi di metaregressione possono essere distorte da fattori di confondimento, perchè non è detto che la relazione tra variabile dipendente e covariate dimostrata between trials -soprattutto se queste rappresentano valori medi di dati ricavati dal trial - possa essere confermata anche within trial, cioè a livello di ciascun studio sot