Area Cardiovascolare [Numero 46 - Articolo 4. Luglio 2010] Il trattamento ipotensivo iniziato con l’associazione di due farmaci si associa ad una ridotta frequenza di interruzione della terapia. Evidenze derivate dalla pratica quotidiana |  |
É noto che le terapie ipotensive vengono spesso interrotte e che questo fenomeno contribuisce significativamente a determinare lampiamente documentato scarso controllo dei valori pressori. La frequenza con la quale si verificano le interruzioni dipende da molti fattori, tra cui la classe di farmaci utilizzata (diuretici e beta-bloccanti si associano ad un più elevato tasso di interruzione) e dallo schema terapeutico (monoterapia o terapia di associazione) adottato. Le linee guida della Società Europea dellIpertensione (1), infatti, consigliano di iniziare il trattamento con una terapia di associazione con lobiettivo di ottenere un più rapido ed efficace controllo dei valori pressori e, di conseguenza, una maggiore compliance, sulla base di alcuni studi sperimentali che documentano lefficacia di questo approccio. Il presente lavoro si propone di verificare se la relazione tra schema di inizio della terapia ipotensiva e tasso di discontinuazione è documentabile anche nella pratica clinica quotidiana.
Metodi
Lo studio è stato condotto utilizzando le prescrizioni di farmaci ipotensivi contenute in due database: il CDL (Claims Database of Lombardy), contenente dati amministrativi relativi allutilizzo di risorse sanitarie a carico del servizio pubblico in Lombardia, ed il CSD (Cegedim Strategic Data longitudinal patient database), alimentato dalle informazioni delle cartelle cliniche computerizzate di oltre 700 Medici di Medicina Generale italiani. Rispetto al CDL, il CSD ha il vantaggio di contenere anche dati clinici quali la severità dellipertensione e la presenza di comorbilità. In entrambi i database sono stati estratti i pazienti di età compresa tra 40 e 80 anni che avevano ricevuto almeno una prescrizione di un farmaco antiipertensivo (ace-inibitori, sartani, calcio-antagonisti, diuretici, alfa-litici, beta-bloccanti, associazioni pre-costituite) nel periodo compreso tra gennaio 2004 e agosto 2007. La data della prima prescrizione era considerata come data indice. Erano esclusi i pazienti che nei 12 mesi precedenti la data indice avevano ricevuto una o più prescrizioni di farmaci ipotensivi e quelli che nei 12 mesi successivi alla data indice avevano ricevuto una sola prescrizione. A partire dalla data indice, le prescrizioni successive venivano considerate come appartenenti allo stesso ciclo terapeutico se effettuate entro 90 giorni dal termine della fornitura di farmaci effettuata con la prescrizione precedente. Se, invece, si riscontrava una ass@enza di prescrizioni per oltre 90 giorni, la terapia era considerata interrotta. La durata della copertura di una prescrizione veniva stimata dividendo la quantità di farmaco prescritto per la corrispondente dose definita giornaliera. Per un sottogruppo di pazienti del database CDS, per i quali era disponibile la posologia dei farmaci ipotensivi, è stato possibile effettuare un calcolo più accurato dividendo la quantità di farmaco prescritto per la dose giornaliera effettivamente assunta.
Sono stati analizzati i dati di 433.680 pazienti nel CDL e di 41.199 pazienti nel CDS. In entrambe le coorti si è documentato come la grande maggioranza (circa due terzi) dei pazienti riceve come terapia iniziale una monoterapia costituita da un farmaco non-diuretico, il 13-14% riceve solo un diuretico, il 15-18% una associazione precostituita, il restante 5-6 % inizia la terapia con una associazione estemporanea di 2 o più farmaci. La più elevata percentuale di interruzioni della terapia, intorno al 65%, si è verificata nei pazienti trattati in monoterapia con diuretico. Frequenze progressivamente più basse sono state riscontrate per la terapia di associazione precostituita, la monoterapia con un farmaco non-diuretico, lassociazione estemporanea con un diuretico, la terapia di associazione estemporanea non comprendente un diuretico. I risultati relativi alla coorte CSD sono rappresentati nella figura seguente (D = diuretics).
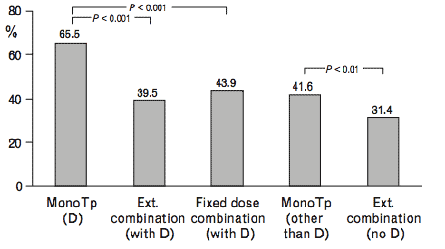
Gli autori concludono affermando che la terapia iniziata con una combinazione di farmaci si associa ad una frequenza di interruzione del trattamento significativamente inferiore rispetto alla monoterapia.
Lo studio presenta alcuni limiti metodologici. La durata della scorta di farmaci corrispondente a ciascuna prescrizione è stata valutata facendo ricorso alla dose definita giornaliera e, pertanto, in modo necessariamente approssimativo. Tale circostanza tuttavia non dovrebbe aver compromesso la validità dei risultati, come dimostrato dalla loro coerenza con i risultati del sottogruppo della coorte CSD per il quale erano disponibili le posologie dei singoli farmaci. Un altro possibile limite è rappresentato dal fatto che i farmaci ipotensivi considerati potrebbero essere stati prescritti per patologie diverse dalla ipertensione e, soprattutto i diuretici, con schemi terapeutici non necessariamente continuativi. Infine, il carattere osservazionale dello studio rappresenta senzaltro un vantaggio per la possibilità di osservare ciò che accade al di fuori del contesto artificiale di uno studio sperimentale e che, pertanto, possiamo aspettarci di riscontrare nella pratica quotidiana. Tuttavia, in queste condizioni è difficile poter escludere con certezza qualsiasi fattore confondente per cui le associazioni riscontrate tra approccio terapeutico e frequenza di interruzione del trattamento rappresentano un argomento debole a favore di un vero e proprio nesso di causalità.
Lo studio è di grande interesse per il medico di famiglia. Controllare e favorire la compliance alla terapia delle principali patologie croniche é uno dei compiti fondamentali del Medico di Medicina Generale. Lipertensione arteriosa è tra le patologie croniche che più direttamente sono gestite dal Medico di Medicina Generale il quale molto spesso si trova ad impostare la terapia del paziente neo diagnosticato. Il presente studio porta ulteriori argomenti a sostegno della opportunità di iniziare una terapia ipotensiva con una associazione di farmaci piuttosto che con una monoterapia, evidenziando lefficacia di questo approccio anche nel favorire la persistenza alla terapia.
Larticolo riveste un elevato interesse pratico e si presta a diverse considerazioni. Innanzi tutto viene ancora una volta documentato il fatto che le terapie ipotensive sono interrotte in una percentuale molto elevata di casi. Anche non considerando i trattamenti iniziati con il solo diuretico, che rappresentano il 13-14% dei casi, la frequenza di interruzioni si attesta intorno al 40%. É quindi giustificato ogni sforzo finalizzato a mantenere una più elevata persistenza al trattamento, Il lavoro, inoltre, documenta, su due differenti casistiche, il dato che la grande maggioranza dei pazienti ipertesi (circa l80%) inizia la terapia con un solo farmaco ipotensivo, nonostante che le linee guida suggeriscano, soprattutto nei pazienti con valori pressori più elevati o con profilo di rischio maggiormente compromesso, di iniziare con una terapia di associazione. Questa, infatti, può garantire un risultato maggiore, in tempi più stretti e con minori effetti collaterali, vantaggi che dovrebbero tradursi in una maggiore aderenza e persistenza alla terapia e, quindi, in un più elevato grado di controllo dei valori pressori. Il lavoro in esame evidenzia che, anche in un contesto non sperimentale, linizio del trattamento con una terapia combinata si associa ad una minore frequenza di interruzioni. Ciò dovrebbe indurre a modificare il nostro approccio al trattamento iniziale del paziente iperteso, almeno nei casi in cui è altamente probabile che la monoterapia fallisca nel raggiungere il target pressorio ed è prevedibile che si debba procedere a modificazioni successive dello schema terapeutico prima di raggiungere un risultato soddisfacente. Un risultato difficile da interpretare è rappresentato dalla constatazione che la terapia con una associazione precostituita non sembra produrre alcun vantaggio, in termini di persistenza, rispetto alla associazione estemporanea. Una ipotesi potrebbe essere che le associazioni precostituite in Italia, soprattutto nel periodo a cui si riferiscono i dati del lavoro, sono prevalentemente costituite da un farmaco attivo sul sistema renina-angiotensina e da un diuretico tiazidico a basso dosaggio. Le associazioni estemporanee, invece, possono contenere uno spettro più ampio di classi di farmaci e di dosaggi e pertanto avere una efficacia terapeutica superiore. Inoltre, il beneficio maggiore, in termini di compliance (2), sembra essere determinato dal numero delle somministrazioni giornaliere piuttosto che dal numero di farmaci adoperati. É quindi possibile che in un numero significativo di casi anche le associazioni estemporanee siano state prescritte in un regime di monosomministrazione, così eguagliando leffetto sulla compliance della associazione pre-costituita.
- ESC, ESH. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal 2007; 28, 14621536. (link: http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-AH-FT.pdf )
- Eisen SA, Miller DK, Woodward RS, Spitznagel E, Przybeck TR. The effect of prescribed daily dose frequency on patient medication compliance. Arch Intern Med. 1990;150(9):1881-4.



