Area Cardiovascolare [Numero 36 - Articolo 2. Aprile 2009] Benefici a lungo termine della terapia con bezafibrato per aumentare il colesterolo HDL. Mortalità a 16 anni dello studio BIP: prevenzione dell’infarto con bezafibrato |  |
Studi precedenti hanno dimostrato una correlazione inversa tra i valori di colesterolo HDL e il rischio cardiovascolare, nei pazienti con valori normali o elevati di colesterolo LDL. Di conseguenza, le linee guida NCEP-ATP III indicano che il colesterolo HDL basso è un elemento importante del punteggio di Framingham, e quindi dovrebbe essere considerato un fattore di rischio cardiovascolare maggiore. Nonostante queste raccomandazioni, dati recenti mostrano che una sostanziosa proporzione di pazienti affetti da malattia coronarica, trattati con statine e modificazioni dello stile di vita, hanno valori bassi di colesterolo HDL. Lo studio di prevenzione dell’infarto con bezafibrato (BIP) era stato disegnato per valutare l’effetto dell’aumento dei valori di colesterolo HDL e della diminuzione dei trigliceridi sul rischio cardiaco in pazienti già affetti da malattia coronarica, e con valori di colesterolo totale normali o poco elevati. Il trattamento con bezafibrato nello studio BIP era associato a riduzione degli infarti miocardici non fatali; ma i tassi di mortalità nei due gruppi erano simili, con riduzione statisticamente non significativa degli obbiettivi combinati (eventi cardiaci fatali e non fatali) nel corso dello studio. Analisi mirate eseguite dopo il termine dello studio mostravano però aumento di beneficio con il trattamento a due anni di distanza, e maggiore riduzione del rischio di morte cardiaca in questo periodo, nei pazienti con aumento di colesterolo HDL >8 mg/dl in terapia con bezafibrato (terzile superiore). Gli autori hanno acquisito i dati di mortalità a 16 anni di tutti i partecipanti allo studio BIP, valutandoli in questo lavoro; ipotizzando che:
- la riduzione di infarto miocardico non fatale nei pazienti trattati a suo tempo con bezafibrato ha avuto un effetto ancora maggiore nella conseguente mortalità a lungo termine
- il grado di risposta dei valori di colesterolo HDL e trigliceridi alla terapia con bezafibrato è associato indipendentemente alla sopravvivenza lungo termine.
Nello studio BIP, 3.026 pazienti, di entrambi i sessi e età compresa tra 45 e 74 anni, con storia di infarto miocardico o angina e valori di colesterolo totale compresi tra 180 e 250, LDL 180 o inferiore, HDL 45 o inferiore, trigliceridi 300 o inferiori, erano assegnati a caso al trattamento con bezafibrato o placebo. Il periodo mediano di osservazione della fase originale dello studio in doppio cieco era di 6,2 anni. Dopo la sospensione del trattamento, i pazienti erano osservati riguardo alla terapia medica e agli eventi cardiaci per altri 2 anni. Per questo lavoro, i dati di mortalità a lungo termine per tutti i partecipanti allo studio sono stati forniti dal Registro della Popolazione Israeliana del Ministero della Salute, per una mediana di 15,7 anni. Nella analisi primaria condotta per questo studio, gli autori hanno valutato la relazione tra le variazioni dei valori di colesterolo HDL durante la fase in doppio cieco dello studio, e il rischio di mortalità per tutte le cause dopo 16 anni. La risposta al bezafibrato è stata classificata come variazione al terzile superiore (aumento, con la terapia, di colesterolo HDL nel terzo terzile) o al terzile inferiore (aumento al primo o secondo terzile). Gli eventi in questi sottogruppi sono stati confrontati con quelli occorsi nel gruppo assegnato al placebo. Nei 495 pazienti con risposta al terzile superiore, i valori di colesterolo HDL erano aumentati da 8 a 34 mg/dl, mentre nei 1014 pazienti con risposta inferiore la variazione era da -12 a 8 mg/dl. In particolare in questo sottogruppo, 497 pazienti avevano variazione al primo terzile, da -12 a 3 mg/dl, e 517 pazienti al secondo terzile, da 3 a 8 mg/dl. Anche l’effetto del bezafibrato sui trigliceridi veniva analizzato in modo simile: 496 pazienti nel terzile superiore con diminuzione di più di 43 mg/dl; 515 nel secondo terzile con riduzione da 10 a 43; 497 nel primo terzile con riduzione di trigliceridi di meno di 10 mg/dl.
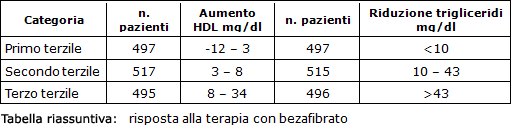
I soggetti esaminati avevano età media di 60 anni, erano di sesso prevalentemente maschile (90%), BMI medio di 26,5: le caratteristiche di base erano simili tra quelli assegnati al placebo, e quelli alla terapia con bezafibrato sia con alta che bassa risposta; anche le caratteristiche cliniche erano simili: pregresso infarto 78%, diabete 10%, ipertensione 33%, BPCO 3%, pressione diastolica (in media) 134, diastolica 81, colesterolo totale 212, LDL 149, HDL 34; solo i trigliceridi erano superiori (150 contro 145) nei soggetti con migliore risposta al bezafibrato. Nel periodo di intervento in doppio cieco, i soggetti assegnati al placebo assumevano in proporzione maggiore (18% contro 10%) altri farmaci ipolipemizzanti, soprattutto statine. Nel successivo periodo di osservazione in aperto di due anni, invece, i fibrati erano assunti dal 10% dei soggetti preventivamente assegnati al placebo, e dal 9% di quelli assegnati al principio attivo, mentre gli altri ipolipemizzanti dal 54% e 51%, rispettivamente.
L’analisi multivariata della mortalità è stata eseguita in funzione del gruppo trattato con bezafibrato, dei sottogruppi di risposta in base ai valori di HDL, e della risposta dei trigliceridi, rispetto al gruppo placebo. La proporzionalità dei rischi è stata valutata con un test basato su covariate in funzione del tempo: età, sesso, abitudine al fumo, classe funzionale NYHA II o superiore, classe funzionale di angina pectoris II o superiore, storia di diabete, infarto, malattia cerebrovascolare, BPCO, ipertensione arteriosa, arteriopatia periferica, pressione sistolica, BMI, frequenza cardiaca, valori basali di colesterolo totale, HDL e trigliceridi. Un’analisi secondaria ha valutato anche gli effetti a lungo termine del bezafibrato nei diversi sottogruppi, stratificati per presenza o assenza di diabete, valori di trigliceridi superiori a 200, BMI superiore a 27, sesso.
Mortalità a lungo termine nei due gruppi di trattamento originali
Il 37,3% pazienti assegnati al placebo (566/1517) sono deceduti nel periodo di osservazione di 16 anni, rispetto al 34,8% (525/1509) di quelli trattati con bezafibrato. La probabilità cumulativa di morte a 16 anni era rispettivamente del 37,9% e 35,3%, corrispondente a una riduzione del 7% del tasso di mortalità nei soggetti trattati. La differenza di mortalità tra i due gruppi era comparsa a partire dal settimo anno di osservazione, mantenendosi poi nel tempo. Le analisi multivariate hanno mostrato una riduzione statisticamente significativa (-11%, P=0,06) del rischio di mortalità a lungo termine nei pazienti assegnati alla terapia con bezafibrato nello studio originale. L’effetto era superiore nelle donne (-27%), nei soggetti con valori basali di trigliceridi elevati (-27%), e in quelli con BMI superiore (-21%).
I tassi di mortalità cumulativa sono stati significativamente inferiori nei pazienti con risposta dei valori di HDL dopo terapia con bezafibrato al terzo terzile: 32,1% rispetto a 37,9% (P=0,02) dei pazienti del gruppo assegnato al placebo, e al 36,8% dei soggetti con valori di HDL dopo terapia ai terzili inferiori. Questo tasso di mortalità inferiore compariva dopo 2 anni di osservazione, e si manteneva nel tempo. L’aggiustamento multivariato per i valori lipidici e la presentazione clinica basale, dimostrava che la riduzione di rischio dell’11% di mortalità a lungo termine dei pazienti trattati con bezafibrato era collegato a una riduzione significativa (P=0,008) del 22% del rischio di morte nei pazienti con risposta al trattamento nel terzo terzile, mentre questo rischio era simile nei soggetti con risposta ai terzili inferiori, e in quelli assegnati al placebo. In particolare, i pazienti con risposta al trattamento al terzile superiore avevano una riduzione del rischio di mortalità a lungo termine del 17% rispetto a quelli con risposta ai terzili inferiori (P=0,04). Tendenze simili erano osservate anche rispetto alla riduzione dei trigliceridi, con differenza statisticamente non significativa della probabilità cumulativa di mortalità a 16 anni tra i tre gruppi, mentre il rischio di mortalità a lungo termine era ridotta del 18% (P=0,03) nei soggetti con risposta al terzile superiore, rispetto al gruppo placebo.
Nella fase in doppio cieco dello studio BIP, 161 pazienti (10,6%) del gruppo placebo e 127 (8,4%) di quelli trattati avevano un infarto miocardico non fatale (P=0.04). Le analisi multivariate hanno dimostrato che l’occorrenza di infarto miocardico non fatale durane lo studio è il fattore predittivo più potente di risultati a lungo termine, essendo associato a un raddoppio del rischio di mortalità a 16 anni. In particolare, il tasso di mortalità a lungo termine era inferiore del 16% nei pazienti trattati rispetto a quelli assegnati al placebo, mentre nei pazienti che non avevano infarto miocardico non fatale durante lo studio, i tassi di mortalità erano sostanzialmente inferiori, e simili nei due gruppi.
Valori bassi di colesterolo HDL sono associati a eventi avversi, anche in pazienti con valori di colesterolo LDL molto bassi. L’aumento dei valori di colesterolo HDL, e la riduzione dei valori di trigliceridi ottenuti trattando i pazienti con bezafibrato, hanno effetti benefici a lungo termine. Il controllo della risposta dei valori lipidici alla terapia con fibrati a breve termine può essere importante nell’identificare un sottogruppo di pazienti (un terzo circa) che rispondono meglio alla terapia, nei quali la sopravvivenza a lungo termine è migliorata, anche dopo la sospensione della terapia attiva con il farmaco.
L’analisi delle variazioni di valori HDL è stata condotta a posteriori, e il confronto tra i terzili non è stato basato su gruppi assegnati a caso, quindi potrebbe essere stato confuso da variabili non legate ai valori lipidici. Gli autori considerano che comunque i risultati non sono variati dopo analisi multivariate per valori clinici e lipidici di base, confermando quindi la possibilità che la riduzione della mortalità a lungo termine, nei soggetti assegnati al trattamento con bezafibrato, possa essere collegata all’effetto del farmaco in studio. Le informazioni sulla mortalità sono complete per tutti i partecipanti allo studio, e per tutto il periodo di osservazione aggiuntivo che si è protratto per altri 10 anni dopo la conclusione dello studio BIP, ma i dati sulle terapie ipolipemizzanti sono disponibili solo per i primi due anni successivi. È quindi possibile che i risultati di questo lavoro siano causati da impiego di terapie ipolipemizzanti non documentate. Gli autori commentano che, in ogni caso, i dati dei primi due anni dopo il termine dello studio BIP dimostrano che i fibrati sono stati prescritti a una proporzione di pazienti simile a quelli originariamente assegnati al bezafibrato, e che le statine sono state prescritte a una porzione di pazienti superiore a quelli inizialmente assegnati al placebo, e a una porzione di pazienti simile ai due gruppi di risposta alla terapia, tra i pazienti assegnati alla terapia con bezafibrato. Quindi, questi dati rinforzano l’ipotesi che la differenza nei risultati a lungo termine tra i due gruppi di trattamento originali (bezafibrato o placebo), è il risultato del farmaco in studio nella prima fase dello studio.
Il lavoro presentato è di grande interesse per la Medicina Generale: dimostra infatti che un’accurata selezione dei pazienti può dare risultati superiori alle attese. Infatti, mentre i risultati del primo studio non erano statisticamente significativi, dopo una selezione dei soggetti in base alla risposta alla terapia, nei soggetti che mostravano maggiore incremento dei valori di colesterolo HDL, la mortalità a lungo termine è significativamente diminuita. Non si tratta quindi di un esercizio matematico, ma di una indicazione pratica, e molto utile. La revisione dello studio BIP fornisce molte altre indicazioni precise ai clinici: la prima è sicuramente l’efficacia della terapia con fibrati, farmaci meno importanti delle statine, che si confermano efficaci e ben tollerati. Il farmaco in studio è il bezafibrato, ma i risultati sono coerenti con altri ottenuti con gemfibrozil, fenofibrato, clofibrato e niacina. La terapia farmacologica si è protratta in media per 6 anni, e a partire da due anni dalla sospensione si sono manifestati gli effetti positivi, mantenutisi fino a 16 anni di distanza. I risultati sono stati migliori nei soggetti con valori di trigliceridi e BMI elevati, fornendo quindi ulteriori criteri di selezione, e nelle donne, che però rappresentano meno del 10% dei pazienti studiati. Lo studio è stato svolto su soggetti di un’ampia fascia di età, da 45 a 74 anni, in media 60, già affetti da malattia coronarica, costituendo una popolazione relativamente poco numerosa tra i pazienti di un Medico di Medicina Generale. Sarebbe interessante poter disporre di ulteriori dati per estendere l’efficacia di questa terapia preventiva a popolazioni più ampie di pazienti. Altri dati utili sono l’importanza dei trigliceridi, la cui risposta alla terapia ha la stessa importanza del colesterolo HDL, e come già detto, la tollerabilità del bezafibrato che è stato associati agli altri farmaci in terapia, in particolare alle statine (peraltro di tipo e dosaggio non specificati), nel 10% dei pazienti durante lo studio, e nel 51% successivamente. Molti argomenti restano comunque aperti, come il ruolo della terapia con statine nel lungo periodo di osservazione, e il meccanismo d’azione del bezafibrato nel ridurre la mortalità a lungo termine, ottenuta soprattutto riducendo gli infarti silenti, fino a 16 anni dopo la sospensione della terapia, come se i valori lipidici non fossero tanto importanti come agente patogeno (i valori basali di colesterolo totale non erano elevati, in media 212), ma piuttosto come indicatori di efficacia della terapia farmacologica.



