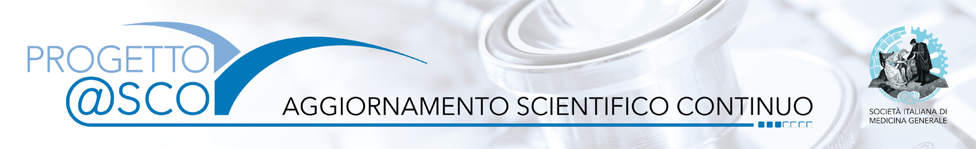Critical Appraisal 2007 Guidelines for the management of Arterial Hypertension |  |
 |
 |
Stesura: 29 Giugno 2007
A cura di: Alessandro Battaggia* e Saffi Ettore Giustini, Comitato Nazionale SIMG Clinical Governance *consulente Dipartimento Farmaceutico ULSS 20 del Veneto -responsabile nazionale SIMG Area del Farmaco. Titolo: 2007 Guidelines for the management of Arterial Hypertension Riferimenti di pubblicazione: Journal of Hypertension 2007 25:1105-1187  |

Gli autori dichiarano di aver aggiornato le linee guida ESH ESC 2003 in seguito alla pubblicazione di nuove evidenze inerenti il management dell’ ipertensione. Era intento degli autori elaborare una linea guida rivolta a tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dell’ipertensione prechè “un corretto management della malattia offre importanti opportunità per implementare interventi su stili di vita rivolti a controllare anche altri fattori di rischio”. Da quanto dichiarato si evince pertanto che la linea guida è dedicata a medici, infermieri, farmacisti e a qualsiasi altro operatore sanitario implicato nella gestione di questa malattia. Il documento non contiene alcuna sezione dedicata in modo specifico al paziente. Nella loro introduzione gli autori non definiscono con chiarezza la popolazione target: solo la lettura dell’intero documento chiarisce al lettore (p. 1141 e 1110) che la linea guida è dedicata non solo al management dell’ipertensione arteriosa non complicata ma anche alla gestione dei pazienti affetti da ipertensione secondaria, dei pazienti ipertesi con e senza danno d’organo, dei pazienti ipertesi con o senza precedenti cardiovascolari. Viene sostenuta fermamente dagli autori la necessità di elaborare raccomandazioni di buon comportamento clinico che non abbiano valenza di protocolli coercitivi e che permettano di valorizzare sempre e comunque la scelta personale del medico, unica figura in grado di “personalizzare il trattamento a seconda delle singole circostanze”.
Formato e chiarezza del documento
Il documento è diviso in capitoli (Introduzione ed obiettivi, Definizione e classificazione dell’ ipertensione, Valutazione diagnostica, Evidenze a sostegno delle raccomandazioni terapeutiche, Approccio terapeutico, Strategie terapeutiche, Approccio terapeutico in condizioni particolari, Trattamento dei fattori di rischio associati, Screening e trattamento delle forme secondarie di ipertensione, Follow-up, Implementazione, Appendici, Bibliografia). La linea guida descrive con sufficiente precisione i singoli problemi clinici , che vengono efficacemente riassunti in appositi Box. Anche i titoli dei capitoli e dei paragrafi guidano il lettore nella scelta dei vari argomenti. Il documento, quando necessario, presenta una serie di possibili opzioni ed identifica le condizioni cliniche che condizionano il controllo dei pazienti e la scelta di farmaci utilizzati per un ottimale controllo. La linea guida appare però abbastanza carente in indicazioni chiave: non sempre cioè risulta facile al lettore attribuire “un rango di importanza operativa” alle singole indicazioni. Inoltre la linea guida non è correlata di algoritmi. A livello di singola raccomandazione gli autori esplicitano i rischi connessi con l’adozione delle singole “indicazioni” in modo molto occasionale mentre più dettagliata appare la descrizione dei benefici attesi.
Gruppo di progetto ed esperti esterni
Gli autori identificano il gruppo multidisciplinare che ha elaborato la Linea Guida ma senza precisare le singole competenze (questi documenti di solito vengono elaborati attraverso il contributo di statistici, epidemiologi, specialisti esperti in contenuto, infermieri, legali, Medici di Medicina Generale, amministratori, rappresentanti dei pazienti). Manca inoltre qualsiasi dettaglio sui ruoli esercitati dai singoli componenti nella produzione del documento. In particolare non viene indicato chi sia stato incaricato di selezionare, classificare e valutare la qualità delle pubblicazioni scientifiche e chi sia stato incaricato di assemblare le singole evidenze in raccomandazioni di buon comportamento clinico. La linea guida non descrive di aver utilizzato tecniche utili a considerare il punto di vista e le preferenze del paziente, argomento affrontato in modo estremamente generico (per esempio a pagina 1165 viene suggerito semplicemente di “tarare la terapia sui bisogni e sullo stile di vita del paziente”).
Normalmente la bozza di una linea guida dovrebbe essere “validata” da un gruppo di esperti estranei al gruppo di progetto. Questo panel dovrebbe essere composto da esperti di contenuto e da esperti di metodo e nessuno di essi dovrebbe aver partecipato alla stesura della LG. Dovrebbe essere esplicitato il metodo utilizzato per raccogliere il loro parere e dovrebbe essere presentata una lista dei componenti del panel con le rispettive competenze professionali. Il documento cita un gruppo di “Document Reviewers” diretto da un “CPG Review Coordinator” ma non chiarisce ruoli, competenze e metodi utilizzati per l’estrazione del consenso dal pool. Non risulta infine che la linea guida sia stata sperimentata da un gruppo pilota nè risulta che ne sia stato previsto l’utilizzo.
Ricerca sistematica delle evidenze e costruzioni delle raccomandazioni
Viene molto ribadita dagli autori la necessità di accompagnare le singole raccomandazioni a referenze bibliografiche prodotte da una vasta e ragionata sintesi della letteratura. Ed è sottolineata a questo proposito la necessità di fare riferimento prioritario ai risultati prodotti da trial randomizzati e controllati -quindi da studi caratterizzati da alta validità interna- ma allo stesso tempo viene dichiarata l’opportunità di attingere è qualora ritenuto necessario - anche da evidenze prodotte da disegni più deboli “a patto che siano rispettati standard elevati di qualità”.
Nonostante queste dichiarazioni la linea guida non riporta alcun dettaglio sul metodo con cui è stato elaborato il documento.
Gli autori non specificano per esempio come sia stata condotta la ricerca bibliografica: non descrivono le fonti di evidenza esplorate, non descrivono la precisa sintassi di ricerca bibliografica sui database, non esplicitano i criteri di inclusione e di esclusione della letteratura revisionata.
ciò rappresenta una grave lacuna di metodo in quanto il primo presupposto di una linea guida di buona qualità (Institute of Medicine, 1992) è che sia elaborata attraverso un processo sistematico e trasparente, descritto dagli autori in modo esplicito per garantire a chiunque la possibilità di riprodurlo.
Una linea guida dovrebbe associare a ciascuna raccomandazione la lista delle evidenze sulle quali è stata costruita e, preferibilmente, anche la descrizione dei contenuti e della qualità della letteratura utilizzata. Il documento ESH ESC cita numerosissime voci bibliografiche, ma non esplicita da chi siano state reperite le evidenze, in che modo esse siano state reperite e per quale motivo esse debbano essere considerate scientificamente affidabili. l’ unica informazione fornita al lettore è rappresentata dalle sigle apposte in bibliografia accanto alle singole voci per identificare la loro tipologia (CT = controlled trial, GL= guideline/export opinion, RT= randomized trial e così via vedi pag. 1166).
Gli autori dichiarano in modo esplicito di aver volontariamente rinunciato ad un qualsiasi metodo di grading per evitare “rigidità” nella formulazione delle raccomandazioni, che non sono pertanto accompagnate da informazioni in grado di indicare all’operatore target il rispettivo “livello di forza e/o d’evidenza”. A nostro parere tutto ciò rappresenta non un plusvalore, ma un ulteriore grave limite di metodo in quanto simile scelta non consente al lettore di verificare il legame tra evidenza scientifica e singola raccomandazione e il livello di forza con cui viene proposta la sua adozione. Quantificare l’importanza di una raccomandazione non solo è utile operativamente a chi deve utilizzare la Linea guida nella pratica professionale (in quanto viene messo nelle condizioni di poter quantificare in modo immediato la solidità di singole opzioni e quindi la fiducia da riporre in esse) ma costituisce ancor più un requisito indispensabile per una linea guida “EBM based” (Grilli, Magrini e Liberati, 2001). Nonostante il grande numero di professionisti coinvolti (15 inclusi in ESC Committee for Practice Guidelines; 19 in ESH Scientific Council, 24 Document Reviewers) la linea guida non specifica in che modo sia stato raggiunto il consenso all’interno del pool. I metodi per estrarre un parere da un gruppo di esperti sono di solito rappresentati da sistemi di votazione o da tecniche molto particolari (un esempio è costituito dal metodo Delphi). Le tecniche formali per raggiungere il consenso presuppongono solitamente che sia chiaramente esplicitato in quali aree e per quali raccomandazioni le opinioni degli esperti siano risultate in disaccordo e il metodo eventualmente adottato per risolvere questo disaccordo. Il fatto che gli autori si limitino a dichiarare che “la qualità della selezione della letteratura” assicurata dalla esperienza accademica e clinica dei membri ESH e ESC attribuisce al documento una spiccata ed ingiustificabile autoreferenzialità.
Indipendenza editoriale e conflitti di interessi
La Linea Guida è prodotta da due importanti società scientifiche della medicina europea. Il documento non fa alcun cenno ai finanziamenti ricevuti eventualmente da organizzazioni esterne. Viene esplicitamente riconosciuto che la maggior parte degli autori coinvolti - oltre che con provider sanitari pubblici e privati - ha collaborato e sta attualmente collaborando con l’industria farmaceutica. Gli autori garantiscono comunque la completa indipendenza delle posizioni individuali con la qualità della produzione scientifica individuale remota e recente.
Anche questa dichiarazione attribuisce al documento una notevole autoreferenzialità. Ad “ulteriore garanzia di trasparenza” gli autori forniscono comunque al lettore due indirizzi web (www.eshonline.org e www.escardio.org) da cui possono essere raccolte informazioni utili a costruire la natura dei rapporti di ciascun componente con le Istituzioni citate.
Revisione delle Linee Guida
Gli autori non descrivono la procedura e i tempi entro cui prevedono di aggiornare il documento.
Implementazione ed audit
Il capitolo dedicato all’implementazione della linea guida analizza il problema in modo molto generico. Il livello di conoscenza del medico e la disponibilità del professionista a recepire le raccomandazioni sono citate dagli autori come principale barriera alla implementazione. In questa sede viene ulteriormente ribadita la necessità di formulare raccomandazioni elastiche e flessibili. La disponibilità del paziente a recepire i consigli del medico e i potenziali ostacoli legati al contesto operativo sono identificati come ulteriori potenziali barriere al cambiamento, verso la cui correzione gli autori formulano consigli di carattere molto generale (box pag. 1164; testo pag. 1165). A livello operativo il documento non include invece alcun materiale di supporto utile all’implementazione (esempio: versione “light” da utilizzare durante l’attività professionale, algoritmi, istruzioni per il paziente, lista dei farmaci con indicazioni e controindicazioni, eccetera). La Linea Guida non descrive indicatori da impiegare nelle procedure di monitoraggio e di audit per misurare la performance basale degli operatori e per valutare a distanza l’effettiva adozione delle raccomandazioni da parte di questi ultimi. Gli autori infine non entrano nei dettagli dei costi connessi con l’adozione delle raccomandazioni e, soprattutto, sul rapporto Costo/Efficacia degli interventi.
Conclusioni
Sotto il profilo del rigore metodologico la stesura di questa linea guida non rispetta nessuno dei tre item riconosciuti necessari per qualificare un documento “EBM based” (Grilli, 2001): identificazione del ruolo dei componenti del gruppo di progetto; identificazione delle fonti di evidenza e del metodo di ricerca sistematica delle evidenze di buona qualità; identificazione di un livello di forza delle singole raccomandazioni. più che una Linea Guida il documento sembra essere un buon “testo” su un argomento assai importante.
A parere di chi scrive la scelta di una Linea Guida sul management dell’ipertensione arteriosa dovrebbe essere quindi orientata su documenti caratterizzati da miglior validità interna.
BOX 1 - Valutazione Linea Guida arteriosa ESH attraverso lo strumento AGREE
Introduzione
Il termine “linea guida” modernamente accettato (LG) coincide con l’interpretazione formulata dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (PNLG 2002) ed esprime il concetto di “percorso assistenziale complesso”. Di norma gli argomenti trattati da una LG riguardano, infatti, non un singolo aspetto dell’assistenza (come può essere ad esempio la terapia farmacologica di una malattia) ma piuttosto le numerose e complesse dimensioni del percorso assistenziale: quella clinica in senso lato (prevenzione, diagnosi, terapia, follow-up), quella organizzativa, quella legata alle interazione degli operatori coinvolti ecc. Quindi una LG deve fornire al lettore non solo una serie di “indicazioni” ricavate dalla letteratura scientifica ma raccomandazioni formulate in modo da garantire la “contestualizzazione operativa” di queste “indicazioni” entro l’ambito del setting locale. Una LG in altri termini deve tener conto di tutta una serie di fattori logistici e di supporto che non sono affatto secondari ma che al contrario sono in grado di condizionare fortemente l’applicabilità delle raccomandazioni nella realtà professionale dove dovranno essere adottate. La tecnologia necessaria per la produzione ex novo di LG è complessa e richiede un ingente impiego di tempo e di risorse. Per la definizione di LG locali è consigliabile pertanto, in primo luogo, considerare quali linee guida sull’argomento esistano nella letteratura internazionale e quale sia la loro qualità. sarà scelta tra queste la LG che corrisponde maggiormente a criteri di qualità prefissati ex ante. Il passo successivo consisterà nell’adattare le raccomandazioni di questa LG al contesto operativo locale (PNLG 2002; Cartabellotta and Potena 2001). Occorre evitare di selezionare due o tre linee guida prodotte da Istituzioni differenti ed effettuare in proprio una sintesi delle loro raccomandazioni: la LG di riferimento deve essere sempre e solo una (Cartabellotta and Potena 2001). Le tappe dei processi di produzione e di applicazione delle linee guida sono descritte in diversi articoli citati dalla nostra bibliografia (PNLG 2002; Cavallo 1999; Marwick, Grol et al. 1992) e non possono essere riprodotte per ragioni di brevità.
Come giudicare la qualità delle linee guida (Appraising) e gli strumenti in sintesi
Il documento Agree (AGREE 2001) riassume pressochè tutti gi elementi che caratterizzano la qualità di una LG. a) La multidisciplinarietà dei gruppi di progetto. È essenziale che il gruppo di progetto che ha prodotto una LG sia multidisciplinare. Il concetto di multidisciplinarietà è più vasto del concetto di multiprofessionalità in quanto ammette la presenza nelle Commissioni anche di figure “laiche” come ad esempio i rappresentanti dei pazienti. La multidisciplinarietà è necessaria per garantire una miglior valutazione dei benefici e dei rischi che ci si aspetta dall’uso delle raccomandazioni da parte di professionalità diverse e di punti di osservazione e valutazione diversi (PNLG 2002). Inoltre favorisce l’integrazione delle dimensioni organizzativa-gestionale, etica ed economica accanto a quella dell’efficacia clinica. Se vengono adeguatamente coinvolti anche rappresentanti dei pazienti essa permette l’integrazione nel documento del punto di vista degli utenti. La multidisciplinarietà del Gruppo di progetto è in particolar modo un requisito importante anche per altri motivi. Studi empirici hanno dimostrato ad esempio che gruppi multidisciplinari tendono ad essere più cauti rispetto a gruppi monodisciplinari nel proporre gli interventi sanitari (Scott and Black 1991; Leape, Park et al. 1992). La condivisione delle raccomandazioni tra medici operanti in diversi setting (ad esempio: territorio ed ospedale) potrebbe probabilmente migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni indotte dagli specialisti sulla medicina generale. Uno studio nazionale ha, infatti, recentemente dimostrato scarsa attenzione da parte degli specialisti sull’appropriatezza delle proprie prescrizioni (Del Zotti, Mezzalira, Battaggia et al. 2001)
Il grading delle raccomandazioni
Ciascuna raccomandazione deve essere classificata secondo due dimensioni valutative (PNLG 2002). Esse sono: I) il livello di evidenza scientifica su cui è costruita la raccomandazione e II) il livello di forza con cui viene proposta la sua adozione. È da notare che mentre esiste un accordo unanime sulla necessità di sottoporre a grading tutte le raccomandazioni di una LG evidence-based, non esiste invece unanimità su come procedere operativamente a questa valutazione bidimensionale.
- Il livello di evidenza (Level of Evidence)
Esistono vari metodi per valutare la qualità delle evidenze scientifiche, sostanzialmente basati sulla validità interna dei disegni degli studi da cui le evidenze sono state estratte. Il metodo proposto dal Centro per la valutazione dell’efficacia dell’Assistenza Sanitaria di Modena è stato adottato dal Programma Nazionale per le Linee guida (PNLG 2002). Il livello di evidenza viene espresso in numeri romani da I a VI. Esso si riferisce alla probabilità che un certo numero di conoscenze sia derivato da studi pianificati e condotti in modo tale da produrre informazioni valide e prive di bias (= errori sistematici dovuti ad incongruenze di metodo) (PNLG 2002). - Il livello di forza delle raccomandazioni (Strenght of Raccomandations)
Alcuni autori correlano rigidamente la forza delle raccomandazioni con il livello delle evidenze scientifiche utilizzate per la messa a punto delle stesse raccomandazioni (Canadian Task Force, 1979) ma un estremo rigore in tal senso ha degli aspetti negativi. In questo modo, infatti, viene valorizzato appieno solo il ruolo degli studi sperimentali e non si tiene conto di situazioni in cui, nonostante la rilevanza del problema, per i motivi più svariati possono essere considerati solo studi osservazionali. Uno studio randomizzato e controllato sugli effetti negativi del fumo per esempio non potrebbe mai essere accettato da un comitato etico (PNLG 2002). Per altri autori la definizione di forza è soggetta a criteri interpretativi più liberi (Gibbons, Chatterjee et al. 1999). Anche un eccesso di soggettività nell’attribuzione del giudizio di forza potrebbe però essere fonte di problemi prechè la metodica potrebbe risultare scarsamente riproducibile. È stata tentata anche l’adozione di metodi sofisticati e complessi (Guyatt, Sackett et al. 1995) dove sono considerate a matrice parecchie variabili ma anche questi possono essere di ostacolo ai potenziali utenti in quanto il loro utilizzo è assai poco intuitivo. Il metodo proposto dal Centro per la valutazione dell’efficacia dell’Assistenza Sanitaria di Modena, adottato dal Programma Nazionale per le Linee guida (PNLG 2002), rappresenta un compromesso accettabile tra le istanze sopra descritte. Il livello di forza del PNLG si riferisce in modo particolare alla probabilità che l’applicazione di una raccomandazione determini un miglioramento dello stato di salute della popolazione verso cui è rivolta. Il link tra livello di evidenza e livello di forza esiste ma la forza dipende anche da altre variabili, quali il peso relativo assistenziale della raccomandazione, i costi attesi, l’accettabilità per gli operatori e per i pazienti, la praticabilità (PNLG 2002).
Gli eventi successivi alla disseminazione di una LG (= processo passivo di trasmissione di informazioni) e alla sue diffusione (= processo attivo, caratterizzato da contenuti educativi) devono consistere in una modifica dei comportamenti professionali (= implementazione delle raccomandazioni). Per verificare se le performance professionali effettivamente migliorano occorre prevedere un sistema di audit organizzato
-
sulla rilevazione della performance basale degli operatori
-
sulla verifica degli scostamenti di questa performance dalle raccomandazioni della LG
-
sulla messa in essere di metodiche atte a favorire la implementazione (non basta la semplice disseminazione e la semplice diffusione della LG!)
-
su una ulteriore verifica a distanza dei livelli di performance raggiunti. Il documento dovrebbe esplicitare chiaramente gli strumenti da utilizzare in ciascuna di queste fasi.
Per esempio dovrebbe fornire (almeno) una serie di indicatori rivolti a fornire informazioni utili sul livello di performance raggiunta relativamente a criteri di qualità ben specificati.