Medicina di genere [MEDICINA DI GENERE] Fumo di tabacco e salute respiratoria nella donna: il ruolo del medico di famiglia |  |
L’OssFAD (Osservatorio su Fumo, Alcol e Droga) dell’Istituto Superiore di Sanità nel 2003 stimava, in assenza di nuove misure per il controllo del tabagismo, un totale nel 2010 di circa 77.000 morti attribuibili al fumo, solo 3000 morti in meno rispetto al 2000 1. Dai dati Istat raccolti nel corso di decenni si può osservare come la percentuale dei fumatori abbia subito una notevole flessione a partire dal 1970, più marcata fino al 1990 e in seguito più lenta (Fig. 1). 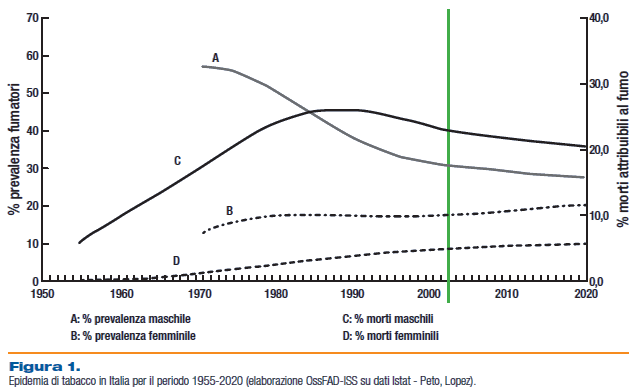 La flessione era dovuta principalmente alla riduzione del fumo tra i maschi, con un massimo del 57% circa all’inizio degli anni ’70, fino a un valore abbastanza stabile, attorno al 31%, dal 2000 in poi. Dal trend degli ultimi 10 anni per gli uomini, si poteva fare stime di una possibile modesta ma progressiva riduzione di lungo periodo, con valori attorno al 29,7 e 27,8% rispettivamente per il 2010 e il 2020. Per quanto riguarda il sesso femminile, al contrario, si è assistito a una continua crescita nell’abitudine al fumo, con un aumento nei primi anni ’90 per le 25-44enni, ma anche per le donne di età maggiore di 45 anni, e un incremento considerevole per le adolescenti. In considerazione del fatto che l’Italia ha un indice di vecchiaia tra i più alti al mondo e un basso tasso di natalità, e tenendo presente l’elevata numerosità delle giovani fumatrici, era plausibile ritenere che nei prossimi anni il numero di donne che fumano potesse aumentare di circa 0,2 punti percentuali ogni anno. Questa stima era fatta in parte a causa dell’aumento del fumo tra le adolescenti che fanno di quest’abitudine un comportamento persistente, in parte alle donne che iniziano a fumare in eta matura, anch’esse in continua crescita. Le proiezioni per il 2020 stimano così un 27,8% di fumatori maschi (6.800.000), mentre per le donne ci si aspettano 5.300.000 fumatrici (20,1%).
La flessione era dovuta principalmente alla riduzione del fumo tra i maschi, con un massimo del 57% circa all’inizio degli anni ’70, fino a un valore abbastanza stabile, attorno al 31%, dal 2000 in poi. Dal trend degli ultimi 10 anni per gli uomini, si poteva fare stime di una possibile modesta ma progressiva riduzione di lungo periodo, con valori attorno al 29,7 e 27,8% rispettivamente per il 2010 e il 2020. Per quanto riguarda il sesso femminile, al contrario, si è assistito a una continua crescita nell’abitudine al fumo, con un aumento nei primi anni ’90 per le 25-44enni, ma anche per le donne di età maggiore di 45 anni, e un incremento considerevole per le adolescenti. In considerazione del fatto che l’Italia ha un indice di vecchiaia tra i più alti al mondo e un basso tasso di natalità, e tenendo presente l’elevata numerosità delle giovani fumatrici, era plausibile ritenere che nei prossimi anni il numero di donne che fumano potesse aumentare di circa 0,2 punti percentuali ogni anno. Questa stima era fatta in parte a causa dell’aumento del fumo tra le adolescenti che fanno di quest’abitudine un comportamento persistente, in parte alle donne che iniziano a fumare in eta matura, anch’esse in continua crescita. Le proiezioni per il 2020 stimano così un 27,8% di fumatori maschi (6.800.000), mentre per le donne ci si aspettano 5.300.000 fumatrici (20,1%).
Per quanto riguarda la mortalità attribuibile al fumo per gli anni 2010-2020 risulta che fino al 1985 la mortalità maschile è stata in continua crescita raggiungendo il picco massimo proprio in questo anno, riflesso dell’elevata prevalenza di fumo di tra i maschi negli anni ’70, a cui segue la fase di declino conseguenza della corrispondente flessione del numero dei fumatori (Fig. 2). 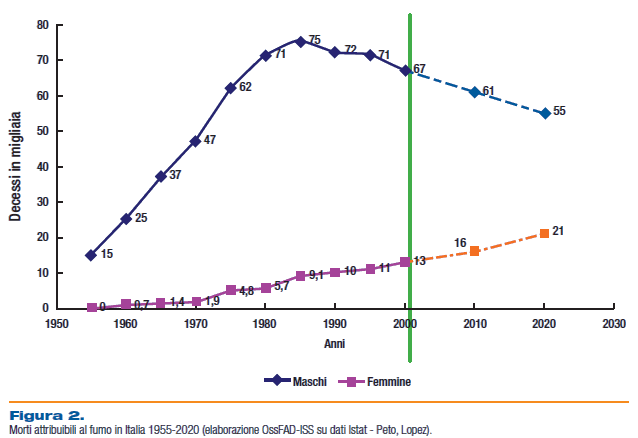 Dal 1985 in poi si osserva una diminuzione delle morti per fumo maschili di circa il 6,2% ogni 10 anni, per cui, assumendo che il trend segua lo stesso andamento per i successivi 15-20 anni e tenendo presente l’andamento della prevalenza in declino, si stimava una riduzione delle morti attribuibili al fumo in Italia di circa 6000 ogni decennio, pari a circa 61 mila nel 2010 e 55 mila nel 2020.
Dal 1985 in poi si osserva una diminuzione delle morti per fumo maschili di circa il 6,2% ogni 10 anni, per cui, assumendo che il trend segua lo stesso andamento per i successivi 15-20 anni e tenendo presente l’andamento della prevalenza in declino, si stimava una riduzione delle morti attribuibili al fumo in Italia di circa 6000 ogni decennio, pari a circa 61 mila nel 2010 e 55 mila nel 2020.
Per quanto riguarda la mortalità femminile la situazione è opposta, nel senso che assistiamo a una continua ascesa, con un incremento sempre maggiore ogni 5 anni: infatti da un aumento di circa il 10% tra il 1985 ed il 1990 e tra questo stesso anno e il 1995, si passa ad un valore del 20% tra il 1995 ed il 2000, con un incremento quasi raddoppiato in 10 anni. Ipotizzando un trend di crescita di simile entità, cui va aggiunta la forte spinta della prevalenza femminile nelle fasce di età giovanili e l’apporto delle donne che continuano a fumare anche dopo i 45 anni, si stimava per i prossimi 15-20 anni un incremento nella mortalità femminile di circa il 40%, che tradotto in valori assoluti, significa circa 4.000 morti in più ogni 10 anni, con una stima pari a 16.000 morti nel 2010 e quasi 21.000 nel 2020.
I dati disponibili più recenti riportati in Figura 3, 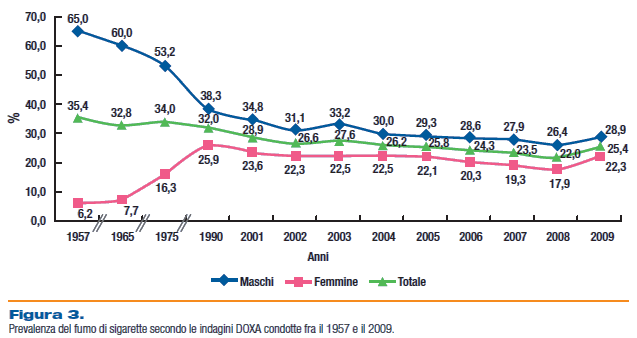 quelli dell’indagine DOXA condotta nel periodo di marzo-aprile 2009 su oltre 3000 persone di età superiore a 15 anni per conto dell’Istituto Superiore di Sanità, sono compatibili con le previsioni del 2003: in Italia il numero dei fumatori, dopo sei anni di costante seppur lieve declino, è nuovamente in aumento 2. L’incremento è del 3,4% e riguarda soprattutto le donne. Il dato è riconducibile a una diminuzione degli ex fumatori, passati dal 18,4% del 2008 al 14,6% del 2009, ma non all’incremento delle vendite di tabacco, che nel 2008 hanno subito una flessione dello 0,9%. Secondo l’indagine, fuma il 25,4% della popolazione, pari a circa 13 milioni di cittadini italiani (7,1 milioni di uomini e 5,9 milioni di donne). L’aumento rispetto al 2008 riguarda più le donne (+4,4%) che gli uomini (+3,4%) e la fascia d’età in cui si registra la prevalenza maggiore di fumatori è quella dei 25-44 anni (32,1%). Nella Figura 3 risulta evidente l’effetto dell’introduzione nel gennaio 2005 della legge che vieta il fumo nei locali pubblici e nei posti di lavoro, che ha comportato una riduzione più marcata della percentuale di fumatori e fumatrici nel periodo 2006-08. Il brusco aumento registrato nel 2009 viene interpretato come la presenza di una soglia di resistenza attorno al 25%, sotto la quale è difficile scendere. Ma conferma anche le complesse dinamiche socio-economiche-culturali del fumo che costringono gli operatori e le agenzie della sanità a non abbassare la guardia nei confronti dell’epidemia tabagica.
quelli dell’indagine DOXA condotta nel periodo di marzo-aprile 2009 su oltre 3000 persone di età superiore a 15 anni per conto dell’Istituto Superiore di Sanità, sono compatibili con le previsioni del 2003: in Italia il numero dei fumatori, dopo sei anni di costante seppur lieve declino, è nuovamente in aumento 2. L’incremento è del 3,4% e riguarda soprattutto le donne. Il dato è riconducibile a una diminuzione degli ex fumatori, passati dal 18,4% del 2008 al 14,6% del 2009, ma non all’incremento delle vendite di tabacco, che nel 2008 hanno subito una flessione dello 0,9%. Secondo l’indagine, fuma il 25,4% della popolazione, pari a circa 13 milioni di cittadini italiani (7,1 milioni di uomini e 5,9 milioni di donne). L’aumento rispetto al 2008 riguarda più le donne (+4,4%) che gli uomini (+3,4%) e la fascia d’età in cui si registra la prevalenza maggiore di fumatori è quella dei 25-44 anni (32,1%). Nella Figura 3 risulta evidente l’effetto dell’introduzione nel gennaio 2005 della legge che vieta il fumo nei locali pubblici e nei posti di lavoro, che ha comportato una riduzione più marcata della percentuale di fumatori e fumatrici nel periodo 2006-08. Il brusco aumento registrato nel 2009 viene interpretato come la presenza di una soglia di resistenza attorno al 25%, sotto la quale è difficile scendere. Ma conferma anche le complesse dinamiche socio-economiche-culturali del fumo che costringono gli operatori e le agenzie della sanità a non abbassare la guardia nei confronti dell’epidemia tabagica.
Al quadro preoccupante per la salute della donna prefigurato dai dati statistici a causa della maggiore esposizione alle sostanze tossiche del fumo, si aggiunge tutta una serie di conoscenze recenti che rivelano una particolare vulnerabilità del sesso femminile nei confronti del fumo. Negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato alcuni elementi che devono essere presenti all’attenzione del medico di famiglia nel suo impegno quotidiano rivolto alla prevenzione e al trattamento della dipendenza dal fumo di tabacco:
-
esistono differenze biologiche nella suscettibilità al fumo tra maschile e femminile evidenziabili a livello cellulare, come dimostra il fatto che la donna che fuma ha un maggior rischio di danno genotossico in seguito a esposizione a raggi ionizzanti rispetto all’uomo 3;
-
il sesso femminile ha di recente sopravanzato gli uomini nella prevalenza mondiale di BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) 4, nonostante il fumo sia prevalente nel sesso maschile e i maschi fumino in media un numero maggiore di sigarette rispetto alle donne 5;
-
nelle donne che fumano il declino della funzionalità respiratoria è più marcato che nei fumatori maschi 6 7, ma più consistente erapido è il recupero in termini di FEV1 (volume espiratorio massimo nel I secondo) che la cessazione dal fumo comporta (Fig. 4):
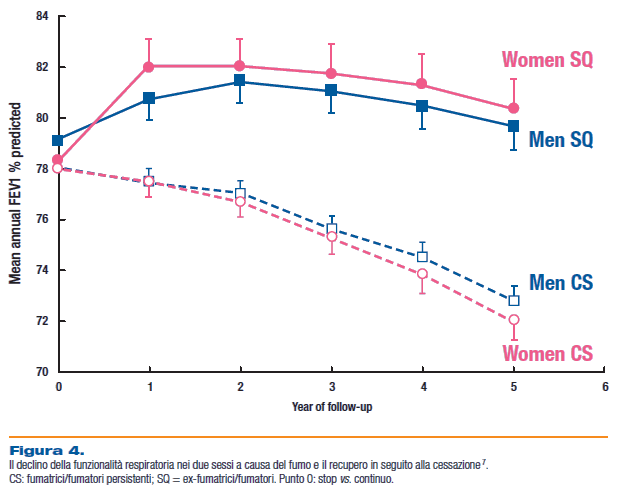 la donna perde l’1,21% di FEV1 per ogni pacco/anno di sigarette (pack years, PY), mentre nell’uomo il FEV1 si riduce solo dello 0,98% per PY 6.
la donna perde l’1,21% di FEV1 per ogni pacco/anno di sigarette (pack years, PY), mentre nell’uomo il FEV1 si riduce solo dello 0,98% per PY 6. -
in presenza di patologie respiratorie come asma e BPCO, il declino della funzionalità polmonare è più rapido nelle donne fumatrici con un danno respiratorio preesistente 8;
-
la donna è più sensibile al fumo passivo: l’esposizione a questo tipo di inquinamento non voluto e facilmente evitabile si è infatti rivelata un fattore di rischio per quanto riguarda i sintomi respiratori e la qualità di vita nel suo insieme 9 10;
-
la particolare sensibilità della donna ai fattori di inquinamento ambientale urbano (PM10), moltiplica il rischio di patologie respiratorie nelle donne che fumano: entrambe le esposizioni rappresentano un binomio temibile nello scenario attuale e futuro dei rischi respiratori 11 12.
-
l’aumento delle donne fumatrici è soprattutto appannaggio delle fasce in età giovanile, cosa che aumenterà il numero di casi di fumo in gravidanza, con le gravi conseguenze che questa situazione comporta.
Cosa potrà fare il medico di famiglia? Per tutte le sue assistite dovrà avere una particolare attenzione nel registrare lo stato di fumatrice e indagare su una loro eventuale esposizione al fumo passivo a casa o sul lavoro. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, va sottolineato che nonostante il generale rispetto della legge Sirchia a livello nazionale nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro di medie-grandi dimensioni, rimangono due ambiti in cui l’esposizione al fumo passivo è tuttora senza controllo: i luoghi di lavoro privati di piccole dimensioni, dove spesso la legge non viene rispettata, e le abitazioni private, che da molti fumatori sono considerate l’ultimo baluardo della propria libertà personale per quanto riguarda un’abitudine da molti considerata ancora “voluttuaria” invece che una vera e propria dipendenza. In questi due contesti l’esposizione al fumo passivo rappresenta un rischio rilevante per la salute respiratoria della donna, considerando anche la possibilità, tutt’altro che rara, dei casi di gravidanza, in cui le conseguenze del fumo passivo risultano particolarmente dannose 13.
La cessazione del fumo nella donna è l’altro impegno che i medici di famiglia devono assumersi, in modo coordinato con i centri antifumo, gli specialisti, il personale infermieristico, le farmacie e le altre agenzie di prevenzione, educative, culturali e amministrative, all’interno di quella che viene definita la “Rete nazionale degli operatori della prevenzione” 14. Sfruttando queste sinergie si potranno raggiungere ottimi risultati in due compiti altrimenti difficili da superare: ridurre l’esposizione al fumo passivo del personale femminile all’interno dei luoghi di lavoro privati e favorire la cessazione dal fumo nella donna. Grazie al loro osservatorio privilegiato, i medici di medicina generale potranno inoltre contribuire a ricerche di tipo ambientale e sociologico necessarie per orientare gli interventi di tipo educazionale e preventivo più adeguati.
Bibliografia
-
Rossi S. I fumatori nel 2010 e 2020 e le morti fumocorrelate. OssFAD. Istituto Superiore di Sanità.
http://www.iss.it/binary/pres/cont/fumatori%202010-2020.1131448004.%20pdf -
Il fumo in Italia 2009. Indagine Istituto Superiore di Sanità/ Doxa. www.iss.it/binary/ofad/cont/Zuccaro_Milano_2009_ cartella_stampa.pdf.
-
Wang LE, Bondy ML, de Andrade M, et al. Gender difference in smoking effect on chromosome sensitivity to gamma radiation in a healthy population. Radiation Res 2000;154:20-7.
-
Mannino DM, Homa DM, Akinbami LJ, et al. Chronic obstructive pulmonary disease surveillance-United States, 1971-2000. MMWR Surveill Summ 2002;51:1-16.
-
Center for Disease Control (CDC). State-specific prevalence of current cigarette smoking among adults and secondhand smoke rulesand policies in homes and workplaces-United States, 2005. MMRW Morb Mortal Wkl Rep 2006;55:1148-51.
-
Gan WQ, MAN PSF, Postma DS, et al. Female smokers beyond the perimenopausal period are at increased risk of chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and metanalysis. Resp Res 2006;7:52.
-
Connett JE, Murray RP, Buist AS, et al. Changes in smoking status affect women more than men: results of the Lung Health Study. Am J Epidemiol 2003;157:973-9.
-
Downs SH, Brändli O, Zellweger JP, et al.; SAPALDIA team. Accelerated decline in lung function in smoking women with airway obstruction: SAPALDIA 2 cohort study. Respiratory Research 2005;6:45.
-
Dransfield MT, Davis JJ, Gerald LB, et al. Racial and gender differences in susceptibility to tobacco smoke among patients with chronic obstructive disease. Resp Med 2006;100:1110-6.
-
Carey MA, Card JW, Voltz JW, et al. It’s all about sex: male-female differences in lung development and disease. Trends Endocrinol Metab 2007;18:303-13.
-
Bridevaux PO, Cornuz J, Gaspoz JM, et al.; SAPALDIA Team. Secondhand Smoke and Health-RelatedQuality of Life in Never Smokers. Results From the SAPALDIA Cohort Study 2. Arch Intern Med 2007;167:2516-23.
-
Schikowski T, Sugiri D, Ranft U, et al. Long-term air pollution exposure and living close to busy roads are associated with COPD in women. Respiratory Research 2005;6:152.
-
Protection from exposure to second-hand tobacco smoke. Policy recommendations. Geneva: WHO 2007.
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/who_%20protection_exposure_final_25June2007.pdf -
Piano nazionale di formazione sul tabagismo rivolto a pianificatori regionali ed operatori pubblici e del privato sociale. Ministero della Salute, Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, Direzione Generale Prevenzione Sanitaria. CCM, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. 2004.
http://www.ccmnetwork.it/documenti_Ccm/%20convegni/convegno_fumo_2008/Laezza.pdf



