Area Dolore – Cure Palliative [Numero 35 - Articolo 4. Marzo 2009] Gestione della lombalgia |  |
Gli autori per questo articolo hanno riesaminato le pubblicazioni con ricerche su Medline, Embase ed Ovid così come dalla Cochrane Library. A tale scopo hanno utilizzato parole chiave quali low back pain crossate con varie categorie di ricerca (come epidemiology, surgery) per ogni sezione. Hanno dato particolare rilievo a revisioni sistematiche della letteratura internazionale, metanalisi e trials randomizzati. In questo articolo gli Autori mirano a fornire una generale descrizione della lombalgia per i medici di assistenza primaria. La lombalgia è la causa principale di invalidità occupazionale nel mondo e la più comune ragione di assenteismo sul lavoro. La popolazione va invecchiando, la vita moderna diviene sempre più sedentaria e questa situazione è difficilmente reversibile. Gli studi epidemiologici più frequentemente citati riportano che il tasso di prevalenza della lombalgia nel corso della vita di un soggetto adulto varia dal 50% all’80%. Eppure tali statistiche sembrano sottostimare il problema. I tassi di prevalenza riportati potrebbero dipendere dal tipo e frequenza di approfondimento diagnostico utilizzato.
Quali elementi della storia clinica e dell’esame obiettivo possono aiutare ad identificare la causa?
Storia clinica
Il box 1 elenca le cause della lombalgia. In linea di massima l’origine del dolore può essere distinta in meccanica, neuropatica o secondaria ad altre cause. La lombalgia meccanica implica che la fonte del dolore si localizzi nella colonna vertebrale od in qualche struttura di sostegno. La lombalgia neuropatica origina invece dall’ irritazione della radice nervosa. Molti sono gli elementi che permettono di distinguere una lombalgia meccanica da una neuropatica nella raccolta della storia del paziente. Molto frequentemente il dolore radicolare è per il paziente una scarica od una pugnalata, mentre quello muscolo-scheletrico, ovvero meccanico, è pulsazione od indolenzimento. Il dolore meccanico spesso si irradia verso la parte superiore della coscia e la regione glutea, l’estensione al di sotto del ginocchio è meno comune rispetto al dolore radicolare. Molti strumenti possono facilitare la distinzione fra dolore neuropatico e nocicettivo. Lutilit? nel distinguere tra algia neuropatica e non neuropatica consiste nella maggiore efficacia di una terapia del dolore mirata al sintomo più che all’eziologia. Le cause meccaniche di dolore lombare, inclusi gli stiramenti muscolari, sono tipicamente peggiorati dal movimento e migliorati dal riposo. In pazienti con discopatia la posizione seduta prolungata, o la flessione in avanti possono aggravare i sintomi. Il dolore associato a stenosi del canale spinale è classicamente rilevato dalla flessione in avanti e peggiorato dall’estensione. Modificazioni sensoriali come formicolii ed intorpidimento possono essere segno di radicolopatia lombosacrale. Sebbene episodi di grave lombalgia possano iniziare durante abituali attività quotidiane, così come derivare da traumi minori, un evento precipitante può talora indirizzare la localizzazione dell’origine del dolore. Tra le varie eziologie di dolore meccanico, la coxalgia è molto spesso associata ad un evento traumatico come una caduta od incidente stradale (40-50%). Nei pazienti che presentano una neuropatia, rispetto alla stenosi del canale spinale, un’ernia discale è più probabilmente associata con un esordio improvviso della clinica e con uno specifico evento scatenante. Le figure dalla 1 alla 3 illustrano alcuni delle più comuni patologie. Accertare la cronicità e distinguere tra le differenti cause dalla clinica desunta da un’accurata anamnesi, potrebbe aiutare a determinare quali pazienti considerare per ulteriori accertamenti e facilitare la stima della prognosi. I pazienti possono avere dolore acuto (ovvero di una durata inferiore alle quattro settimane) non specifico, lombalgia cronica (persistente da più di tre mesi) senza radicolopatia, algia lombare radicolare, o dolore lombare associato con una grave patologia sottostante.
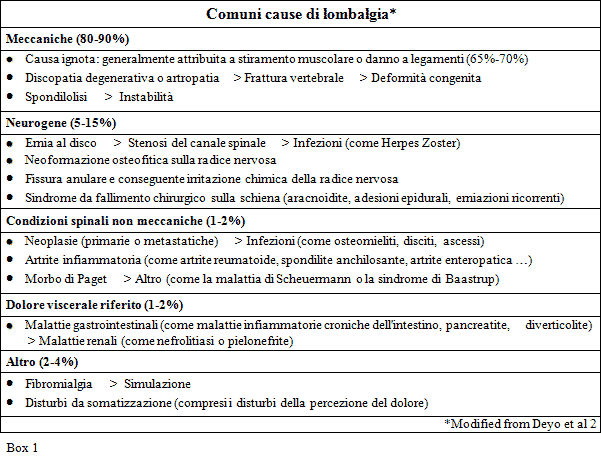
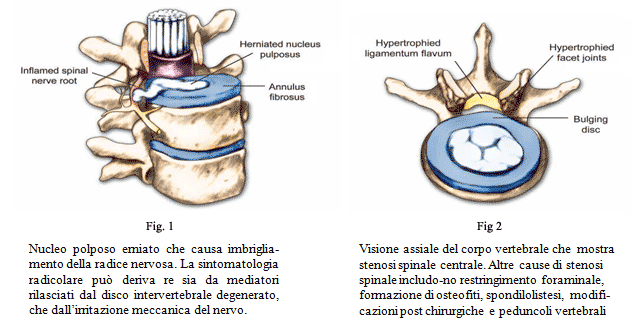 Esame Obiettivo
Esame ObiettivoL’esame obiettivo è generalmente finalizzato ad orientare ulteriori indagini diagnostiche, ma è raramente diagnostico. Potrebbero essere rilevate importanti deformità connesse allo sviluppo od a traumi. Compromissione del sensorio, chiara debolezza neurologica (da differenziare dall’ evitamento antalgico del movimento), riflessi ridotti od asimmetrici alla caviglia od al ginocchio, possono indicare un coinvolgimento delle vie nervose. La tabella 1 sottolinea segni e sintomi d’allarme (red flag), che possono cioè sottendere un’importante patologia sottostante. In pazienti con reperti neurologici franchi o progressivi, può essere necessaria l’esplorazione rettale (e con essa la valutazione della presenza di dolore od il tono sfinteriale), nel sospetto di una possibile sindrome della cauda equina o di un disturbo a livello del cono midollare (tabella 1, box 2, figure 4-6). In una revisione sistematica l’elevazione dell’arto inferiore a ginocchio esteso (segno di Lasègue) si è rivelato il segno più sensibile di sofferenza radicolare, ma tale strumento obiettivo era limitato dalla bassa specificità (sensibilità complessiva 0.85, specificità 0.52). Studi similari condotti valutando il livello di mobilità permesso, si sono imbattuti in una limitazione dovuta alla soggettività degli esaminatori ed alla scarsa correlazione con la compromissione funzionale. La palpazione della colonna vertebrale è spesso impiegata per l’inquadramento della lombalgia; in varie revisioni sistematiche della letteratura tale parametro è risultato essere più affidabile rispetto alla valutazione della mobilità , ma nessun test ha mostrato beneficio nell’orientare l’approccio clinico o nel definire una diagnosi. Per la coxalgia e l’artropatia degenerativa coinvolgente le faccette articolari, nessun elemento nella storia clinica o nell’esame obiettivo risulta predittivo di risposta alla puntura intra - articolare diagnostica.
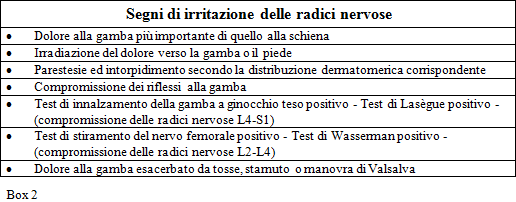
Imaging
L’utilità della diagnostica per immagini in assenza di anomalie strutturali maggiori (come tumori od infezioni) è limitata dall’alta prevalenza di patologie degenerative in adulti asintomatici. Circa il 30% di soggetti asintomatici presenta una protrusione discale alla risonanza magnetica, più della metà ha dischi intervertebrali rigonfi o degenerati, ed un quinto risulta avere fissure anulari. Molti studi hanno indagato per determinare se l’imaging precoce nella lombalgia acuta possa influire sull’ outcome della stessa. Riguardo le radiografie semplici, gli studi condotti non sono riusciti a trovare un beneficio nell’ambito dell’imaging precoce, sebbene pazienti sottoposti ad indagini radiografiche possano mostrare più alti livelli di soddisfazione. Peraltro studi prospettici non hanno trovato benefici nell’indagare sull’efficacia di risonanza magnetica precoce od altre indagini radiologiche in pazienti con lombalgia (indipendentemente dalla presenza di sintomi radicolari). L’assenza di un vantaggio nell’ imaging per la valutazione dell’ algia lombare emerge anche da recenti reviews. Le linee guida dell’American College of Physicians raccomandano la diagnostica per immagini nella lombalgia soltanto in presenza di deficit neurologici severi o progressivi, nel sospetto di una grave patologia sottostante, nello studio di pazienti candidati alla chirurgia od all’iniezione epidurale di steroidi. Nel valutare discopatie, sintomi neurologici o nell’accertare la presenza di fratture vertebrali o metastasi, la risonanza magnetica senza mezzo di contrasto è il metodo d’indagine più sensibile.
Chi sviluppa il dolore cronico?
Tra pazienti valutati per lombalgia in un ambulatorio di assistenza primaria, l’80-90% degli stessi richiede un approccio terapeutico non più lungo di tre mesi. Peraltro recenti studi longitudinali suggeriscono che il 30-40% può presentare persistenza dei sintomi. Numerosi studi prospettici hanno cercato di identificare elementi predittori di episodi di lombalgia acuta, la transizione dolore acuto-dolore cronico e l’invalidità connessa. In generale alcuni fattori psicologici come coesistenza di depressione ed ansia, meccanismi ed atteggiamenti di compenso, stress connesso al lavoro e livello di soddisfazione nello stesso, percezione dei concetti di salute e livello di attività , giocano un ruolo più importante, rispetto alla alla patologia anatomicamente definita, nel predire la persistenza della lombalgia. L’evidenza del ruolo di una psicopatologia concomitante in pazienti con lombalgia acuta lombare è determinante più nel predire cronicità nel dolore ed invalidità relativa, che nuovi episodi di algia acuta. Il box 3 elenca i fattori associati allo sviluppo ed alla persistenza di dolore lombare.
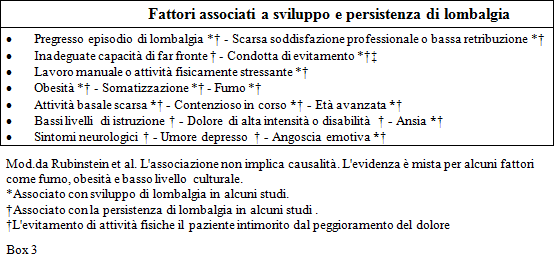
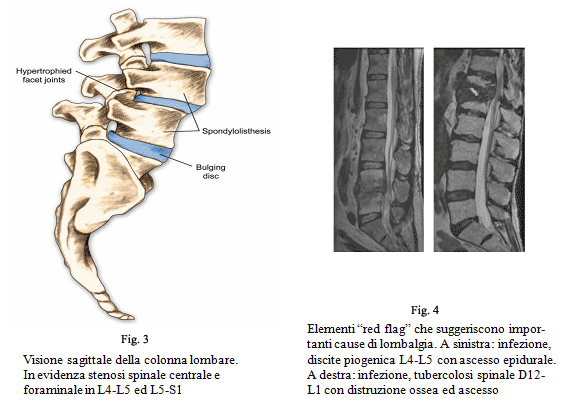
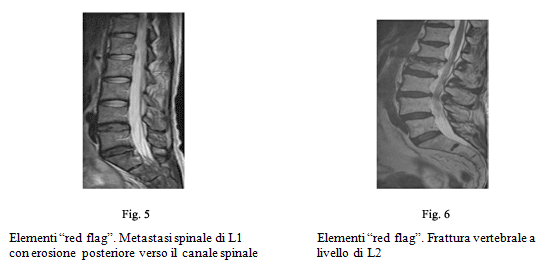
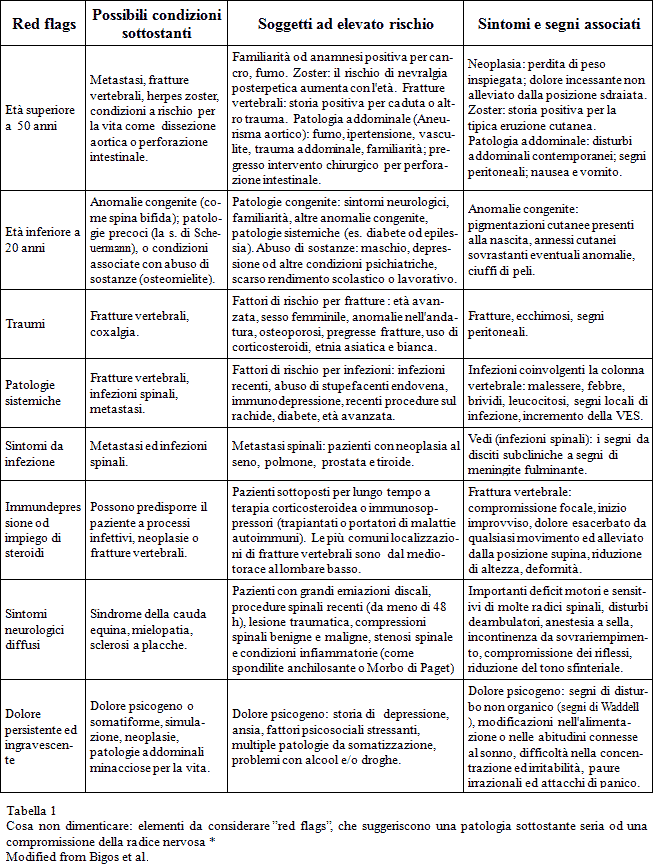
Trattamento
Molti pazienti con lombalgia non cercano cure mediche. Molti ricorrono all’autotrattamento con farmaci da banco e modificazioni dello stile di vita. Molti casi di lombalgia acuta non specifica si risolvono entro due settimane. Rassicurazione e counselling del paziente affinchè non ceda all’inattività sono fondamenti nel trattare questo tipo di dolore, sebbene qualcuno possa beneficiare di forme brevi di farmacoterapia. Una revisione Cochrane segnala come il rimanere attivo nella lombalgia acuta non specifica abbia un piccolo ma consistente effetto positivo su riduzione del dolore e miglioramento funzionale, rispetto al riposo a letto. In pazienti con dolore persistente in presenza o meno di radicolopatia, un regime di trattamento multimodale che includa un programma di esercizio regolare, perdita di peso, psicoterapia se indicata, terapia iniettiva e farmaci, può essere efficace. Quando il dolore deriva da una patologia sistemica rilevante, come neoplasie, la palliazione dei sintomi può essere iniziata contemporaneamente al trattamento primario.
Molte revisioni sistematiche riportano forti evidenze a favore dell’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) nella lombalgia non neuropatica, sebbene l’effetto del trattamento sia minimo e l’evidenza sia maggiore per il dolore acuto che per quello cronico. Il paracetamolo (acetaminofene) è leggermente meno efficace dei farmaci antinfiammatori non steroidei, ma presenta meno effetti collaterali. Esistono minime evidenze che i FANS siano efficaci nella radicolopatia, o che un principio attivo di tale classe farmacologica sia da preferire ad un altro. In pazienti con lombalgia acuta non specifica, elementi di prova supportano un minimo beneficio nell’utilizzo di miorilassanti non benzodiazepinici (come ciclobenzaprina e tizanidina), mentre minimi sembrano essere gli effetti delle benzodiazepine (come diazepam e clonazepam). Nel trattamento della lombalgia cronica sono ancor meno consistenti le evidenze che sostengono l’utilizzo di miorilassanti. Molte revisioni sistematiche della letteratura individuano gli antidepressivi triciclici, ma non gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, quali farmaci più efficaci rispetto al placebo nella lombalgia cronica aspecifica. Nel dolore neuropatico l’NNT (number needed to treat) necessario per ottenere un beneficio significativo dall’utilizzo degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina è più di tre volte superiore rispetto a quello necessario utilizzando antidepressivi triciclici. Esistono poche prove a supporto dell’utilizzo di qualsiasi classe di farmaco nella radicolopatia, ma due studi hanno mostrato un piccolo beneficio derivante dall’utilizzo di gabapentin. Gli oppioidi sono considerati una ragionevole alternativa nel trattamento di alcuni casi di lombalgia acuta, ma il loro utilizzo nell’algia cronica lombare è controverso. In una metanalisi gli autori hanno infatti concluso che, nonostante gli oppioidi possano dare un beneficio di breve durata in alcuni pazienti con algia lombare cronica, il loro effetto a lungo termine rimane poco definito. Sebbene gli oppioidi vengano utilizzati nella lombalgia cronica od in altre condizioni non maligne, molte linee guida sostengono il loro impiego soltanto quando trattamenti più conservativi abbiano fallito, in contemporanea a strumenti di valutazione del rischio connesso, al consenso al trattamento, all’individuazione di obiettivi chiaramente definiti e di eventuali strategie di compenso.
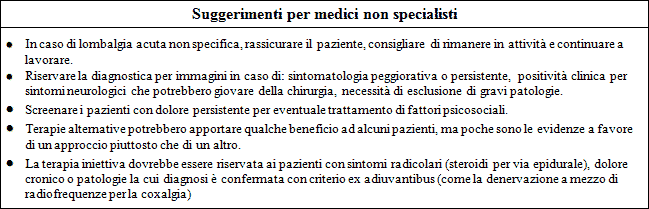
Terapie complementari
I medici riportano sempre più casi clinici di pazienti sottoposti a trattamenti medici complementari ed alternativi; alcuni studi indicano peraltro che più della metà dell’assistenza medica primaria raccomanda o prescrive tali terapie per il mal di schiena. Nelle linee guida pratiche pubblicate congiuntamente dall’American College of Physicians e dall’American Pain Society, vengono citate alcune buone evidenze che supportano numerosi trattamenti alternativi per la lombalgia subacuta (più di quattro settimane) e cronica, compresi agopuntura, yoga, massaggi, manipolazione della colonna vertebrale e rieducazione funzionale. Nell’algia lombare non specifica, prove di efficacia sono state trovate per manipolazione spinale ed applicazione di calore superficiale sotto varie forme. Le evidenze sono invece insufficienti per valutare appieno ogni tipo di terapia alternativa per la radicolopatia, o per indicare la superiorità di un trattamento rispetto all’altro. La tavola 2 riassume le evidenze nell’utilizzo di possibili terapie alternative nella lombalgia.
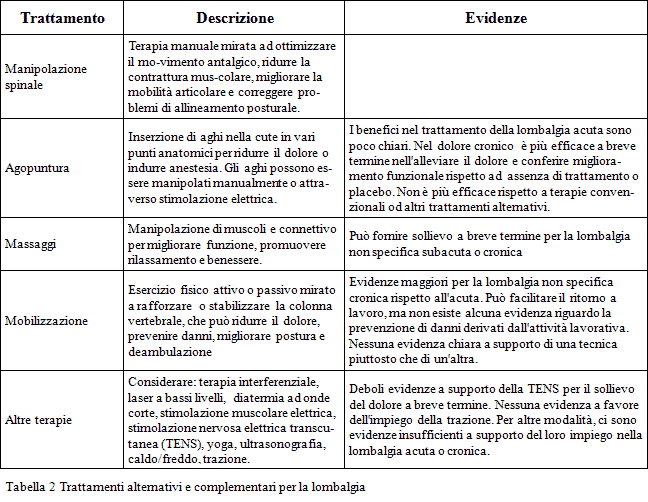
Blocchi nervosi
In pazienti i cui sintomi persistono dopo sei settimane, i blocchi nervosi possono offrire benefici diagnostici e terapeutici. Riguardo l’iniezione lombare epidurale di steroidi, revisioni sistematiche hanno trovato evidenze moderate che procedure guidate fluoroscopicamente possono apportare sollievo a breve termine nel dolore radicolare secondario ad erniazione discale, ed evidenze alternanti relative all’efficacia a lungo termine (sei mesi o più). L’evidenza è più forte per l’iniezione transforaminale rispetto a quella epidurale caudale od interlaminare e rileva maggiore efficacia per il dolore subacuto rispetto al cronico. In un piccolo studio placebo controllato e randomizzato, l’iniezione epidurale transforaminale di steroidi ha ridotto il tasso di interventi chirurgici tardivi. In pazienti con stenosi del canale spinale esistono poche evidenze a sostegno di un beneficio a breve termine; nel dolore lombare non specifico non esistono evidenze consistenti a supporto dell’iniezione epidurale. Trattamenti interventistici per la lombalgia di origine muscolo-scheletrica, sono meno efficaci che per la radicolopatia. In pazienti con sospetto dolore da compromissione delle giunture articolari, esistono poche evidenze a supporto dell’iniezione di corticosteroidi e deboli a favore della denervazione a mezzo di radiofrequenze. Nella coxalgia i risultati degli studi sono insoddisfacenti riguardo il beneficio a breve termine da iniezione intra-articolare di steroidi e deboli per la denervazione con radiofrequenze. Conflittuali le evidenze relative alla terapia elettrotermica nel trattamento del dolore discogenico.
Chirurgia
Gli interventi chirurgici per lombalgia secondaria a patologie maggiori quali infezioni, tumori e fratture sono spesso efficaci nel proteggere le strutture nervose, prevenire le deformità e nell’alleviare il dolore. In pazienti con radicolopatia persistente derivante da comuni patologie degenerative, la chirurgia può ridurre il dolore e migliorare la funzione. Nell’erniazione discale in assenza di deficit neurologici severi, il principale beneficio della chirurgia può essere un più rapido recupero della funzione rispetto al naturale corso della patologia. Nella stenosi del canale spinale e nella spondilolostesi, l’intervento chirurgico si associa ad eccellenti outcomes, che in genere persistono almeno per due anni dopo. In pazienti con algia lombare cronica che si presentano con i classici segni radiologici di modificazioni degenerative del rachide, interventi chirurgici, come fusione intersomatica o artroplastica discale sono meno efficaci. Se in questo gruppo la chirurgia riesca a dare risultati di gran lunga superiori rispetto ad un programma comprensivo di riabilitazione associato a terapia cognitivo - comportamentale non è chiaro. Soltanto nel 15-40% dei casi in tale contesto patologico può aspettarsi un outcome altamente funzionale dopo la chirurgia.
Promettenti aree di ricerca
Le strategie di trattamento rigenerativo mirano a inibire o rallentare la degenerazione discale; esse includono la somministrazione di fattori di crescita, cellule autologhe od allogeniche, terapia genica e introduzione di biomateriali. Sono peraltro in corso studi miranti a ridefinire criteri di selezione e tecniche per procedure interventistiche. Comunque l’impiego di indagini genetiche per selezionare pazienti al trattamento è limitato dalla complessa relazione fra outcomes e fattori psicosociali. Studi clinici e preclinici hanno individuato le citochine come maggiori intermediari in alcune forme di dolore da irritazione del nervo ischiatico. In tal senso le strategie miranti ad alterare la via di attivazione delle citochine sembra promettente. Infine iniziative di salute pubblica possono ridurre la disabilità nella lombalgia. Uno studio australiano ha infatti valutato l’effetto di una campagna pubblicitaria che invitava i pazienti con lombalgia a restare attivi e continuare a lavorare: è stata rilevata una riduzione degli appelli per disabilità e delle spese mediche.
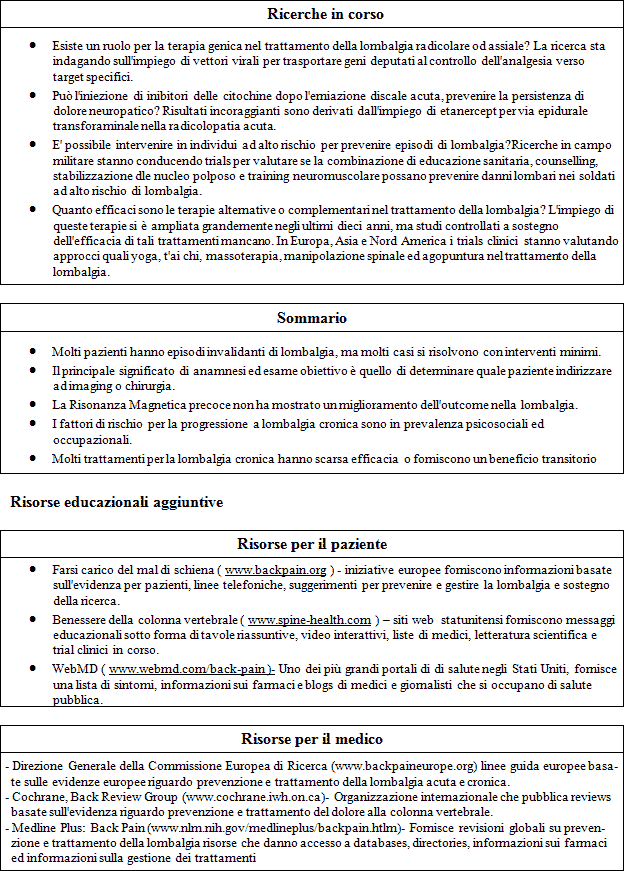
Importanza per la medicina generale
Lassistenza al paziente con la lombalgia è complessa, e prevede varie opzioni. In base alle recenti evidenze, ci si attende un ricorso sempre maggiore ai trattamenti minimali per la gran parte delle lombalgie acute non specifiche. Il suggerimento di uno stile di vita attiva e lattenzione per i fattori psicosociali. Luso della risonanza magnetica precoce solo nei casi selezionati. Luso delle terapie mediche e complementari come da recenti indicazioni e la terapia chirurgica da riservare ai casi specifici.
Commento del revisore
Questa revisione accurata della letteratura esistente rivolta ai Mmg sulla lombalgia, principale causa di disabilità occupazionale nel mondo, se da una parte ci conferma la difficoltà di affrontare delle incertezze diagnostiche e terapeutiche, dallaltra ci offre delle indicazioni importanti di massima su cosa è consigliabile fare e non gli elementi che ci suggeriscono una patologia sottostante seria - quali pazienti selezionare per la diagnostica per immagini limportanza di fattori psicosociali e occupazionali per la progressione della malattia la mancanza di studi validati per terapie complementari o alternative i promettenti sviluppi delle nuove aree di ricerca in corso, le terapie rigenerative ed infine le risorse educazionali disponibili per medici e pazienti.



