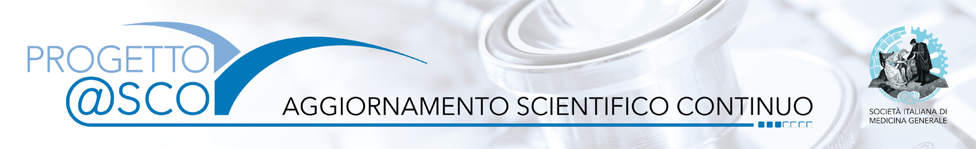Sintesi di LINEE GUIDA [Sintesi linee guida – Area Cardiovascolare] Gestione della fibrillazione atriale |  |
Le linee guida presentate dalla Società Europea di Cardiologia rappresentano le prime linee guida sulla gestione della fibrillazione atriale completamente europee. Sono state introdotte diverse novità rispetto alle precedenti linee guida americane, soprattutto in termini di gestione della terapia farmacologica. Dal punto di vista della classificazione clinica della fibrillazione atriale, è stata aggiunta la nuova voce della FA persistente di lunga durata che include quelle forme di aritmia presenti da oltre un anno e candidate alla cardioversione. Sul versante della terapia farmacologica, ecco le novità:
- indicazioni precise sulla terapia anti trombo embolica, adottando dei profili di rischio che stabiliscono chi meglio potrà beneficiare dei vari farmaci per la prevenzione dellictus
- nuove indicazioni per il controllo della frequenza cardiaca, smentendo i benefici derivanti da uno stretto controllo della stessa
- indicazioni sulluso degli antiaritmici e sul ricorso alla cardioversione
- indicazioni per il controllo di eventuali patologie concomitanti per la prevenzione primaria e secondaria dellaritmia
- indicazioni per categorie selezionate di pazienti.
Vengono anche presentati due nuovi farmaci: lantiaritmico dronedarone e linibitore diretto della trombina dabigatran.
La fibrillazione atriale (FA) è la più comune aritmia cardiaca e interessa l1-2% della popolazione generale. Clinicamente si distinguono cinque tipi di FA in base alla presentazione clinica e alla durata dellaritmia:
- FA di prima diagnosi, primo episodio di FA indipendentemente dalla durata e dai sintomi
- FA parossistica, si autolimita entro 48 ore
- FA persistente, perdura oltre i 7 giorni o richiede cardioversione
- FA persistente di lunga durata, aritmia presente da oltre un anno quando si decide di adottare una strategia di controllo del ritmo
- FA permanente, aritmia accettata dal paziente e dal medico; non si adottano strategie di controllo del ritmo.
Raccomandazioni per la diagnosi e il management iniziale
La diagnosi richiede lesecuzione di un ECG a 12 derivazioni. In pazienti con sospetta FA (irregolarità del polso, sintomi quali dispnea o palpitazioni) si raccomanda lesecuzione di un ECG standard. In caso di negatività, è utile lesecuzione di un ECG Holter 24 ore in presenza di sintomi fortemente suggestivi. Tutti i pazienti affetti da FA vanno sottoposti ad un attento esame obiettivo e alla raccolta dellanamnesi, ricercando il momento di insorgenza dellepisodio aritmico e valutando la severità della sintomatologia, le eventuali complicanze (scompenso cardiaco, stroke o TIA), patologie concomitanti, fattori precipitanti e familiarità. In particolare la valutazione sintomatologica dovrebbe avvenire utilizzando un sistema a punteggio chiamato EHRA score in modo da meglio definire i sintomi lamentati dal paziente (1).
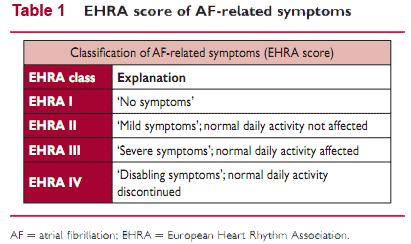
Va quindi effettuata la ricerca di cause sottostanti la FA. Si raccomanda lesecuzione di un ecocardiogramma. Utile il dosaggio degli ormoni tiroidei, glicemia, creatinina ed emocromo. In casi selezionati test di funzionalità epatica ed ECG da sforzo. Il management della FA prevede il raggiungimento di cinque obiettivi: prevenzione degli eventi trombo embolici, regressione dei sintomi, controllo delle patologie concomitanti, controllo della frequenza cardiaca e ripristino del ritmo.
Prevenzione degli eventi trombo embolici
La terapia antitrombotica è raccomandata per tutti i pazienti con FA, eccetto le condizioni a basso rischio e in presenza di controindicazioni. La scelta della terapia antitrombotica deve basarsi sulla presenza di fattori di rischio per eventi trombo embolici, sul rischio di sanguinamento e sui potenziali benefici per un determinato paziente. Per la stratificazione del rischio trombo embolico si utilizza il sistema a punteggio CHADS2 o il più sensibile CHADS2-VASc score che include i cosiddetti fattori di rischio minori (2; 3)
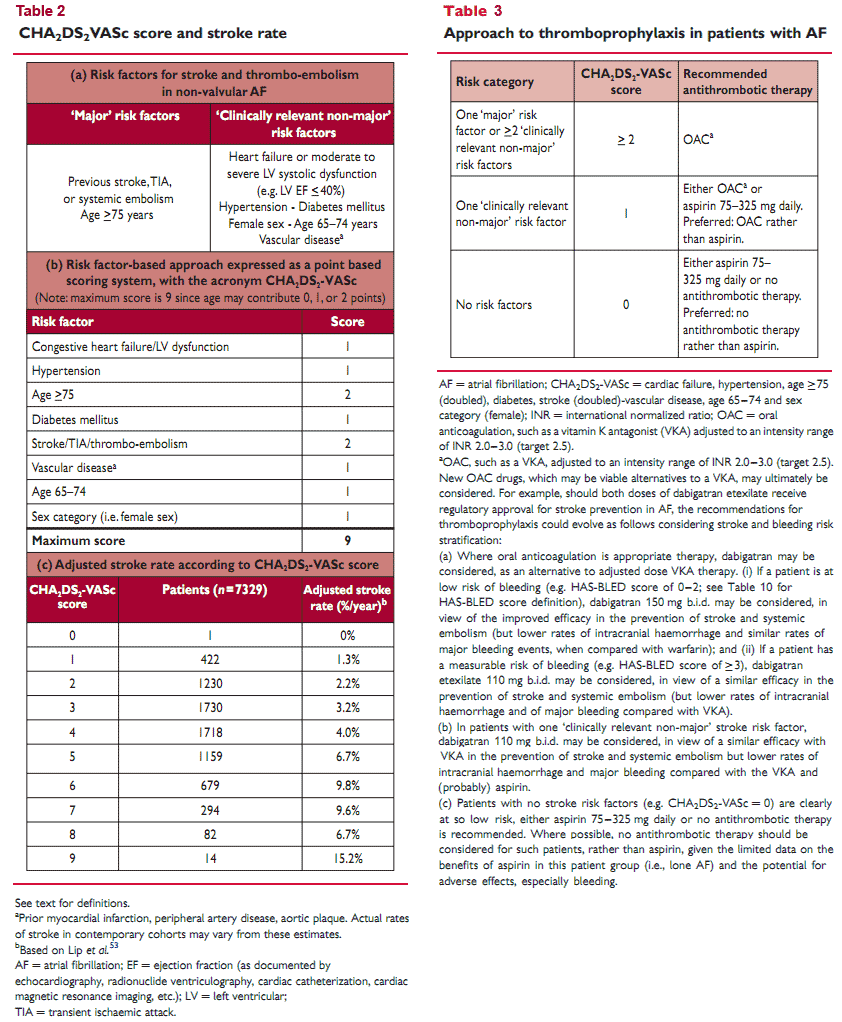
In parole semplici, nei pazienti che non hanno fattori di rischio trombo embolici (cardiopatie, ipertensione, diabete, età > 75 anni, storia di eventi tromboembolici) o con uno o nessun fattore di rischio minore (età 65-74 anni, sesso femminile, vasculopatie) è da preferire lutilizzo di aspirina a dosi comprese tra 75-325 mg/die o nessuna terapia, visti i dati limitati di efficacia dellaspirina in questo gruppo di pazienti e i potenziali eventi avversi, come il sanguinamento. Nelle altre categorie è consigliato lutilizzo di anticoagulanti orali come gli antagonisti della vitamina K con dosaggi variabili in base ai valori di INR che devono essere compresi tra 2 e 3 nelle FA non valvolari. Inizialmente, si raccomanda la contemporanea somministrazione sottocutanea di EBPM che verrà sospesa al raggiungimento del target di INR. Una valida alternativa è un nuovo anticoagulante, inibitore diretto della trombina, il dabigatran: nel RE-LY Study il dabigatran 110 mg bid è risultato non inferiore agli antagonisti della vitamina K nella prevenzione degli eventi trombo embolici con una minore frequenza di sanguinamenti maggiori, mentre alla dose di 150 mg bid risulta associato ad una minore incidenza di eventi trombo embolici con una frequenza simile di emorragie maggiori rispetto agli antagonisti della vitamina K (4).
Management della frequenza cardiaca e del ritmo sinusale in fase acuta
La gravità dei sintomi legati alla FA guida nella decisione tra ripristino immediato del ritmo sinusale o controllo della frequenza cardiaca e ripristino a lungo termine del ritmo. La terapia iniziale dovrebbe sempre includere unadeguata terapia antitrombotica. Pazienti con una rapida risposta ventricolare vanno trattati, se in condizioni stabili, con somministrazione orale di beta-bloccanti o calcio antagonisti non diidropiridinici, se emodinamicamente instabili, con infusione di verapamil o metoprololo. Il target di frequenza cardiaca da raggiungere in fase acuta varia tra 80 e 100 bpm. In pazienti selezionati con funzione ventricolare depressa si può utilizzare lamiodarone. La cardioversione farmacologica è indicata in pazienti emodinamicamente instabili o che rimangono sintomatici nonostante il controllo della frequenza cardiaca. Si raccomanda lutilizzo di flecainide o propafenone in assenza di cardiopatia e di amiodarone in presenza di anomalie cardiache strutturali. La cardioversione elettrica è raccomandata quando la frequenza cardiaca non risponde al trattamento farmacologico e subentrino ischemia miocardica, ipotensione o scompenso cardiaco. Si raccomanda anche nei casi di preeccitazione ed instabilità emodinamica.
In seguito alla cardioversione aumenta il rischio di eventi trombo embolici. Si raccomanda:
- nelle FA insorte da più di 48 ore o ad incerta epoca di insorgenza da sottoporre a cardioversione elettiva, TAO con INR 2-3 da 3 settimane prima a 4 settimane dopo la cardioversione
- nelle FA insorte da meno di 48 ore o FA > 48 ore emodinamicamente instabile, cardioversione sotto copertura eparinica e successivamente TAO solo nei pazienti con fattori di rischio trombo embolici.
Management a lungo termine della frequenza cardiaca e del ritmo sinusale
Un adeguato controllo della frequenza cardiaca migliora i sintomi e la funzionalità miocardica. Si raccomanda a tutti i pazienti con FA ad elevata risposta ventricolare. La scelta del farmaco (beta-bloccanti, calcio-antagonisti non diidropiridinici) e la dose da somministrare variano da persona a persona. La digitale è indicata in pazienti con scompenso cardiaco o disfunzione del ventricolo sinistro. Il livello ottimale di frequenza rispetto a morbidità, mortalità e qualità della vita non è noto: precedenti linee guida indicavano valori a riposo tra 60-80 bpm e dopo sforzo 90-115 bpm sulla base del trial AFFIRM (5). Tuttavia il recente trial RACE II non identifica benefici derivanti da uno stretto controllo della frequenza cardiaca, in quanto sintomi, eventi avversi e qualità della vita risultavano simili nel gruppo di pazienti con frequenza target a riposo < 110 bpm e nel gruppo con target < 80 bpm (6). Una terapia a lungo termine di controllo del ritmo cardiaco è indicata per il sollievo dai sintomi correlati alla FA. Nei pazienti senza cardiopatia strutturale i farmaci di scelta sono dronedarone, flecainide, propafenone e sotalolo. Nei pazienti con scompenso cardiaco classe NYHA III e IV o classe II emodinamicamente instabile, lamiodarone è il farmaco di scelta (N.D.R. Si consigliano controlli TSH, RX Torace). I beta-bloccanti sono raccomandati per la prevenzione della FA con ipertono adrenergico (in corso di tireotossicosi o FA indotta da esercizio fisico). Per quanto riguarda il dronedarone, lo studio DIONYSOS ha dimostrato la minore efficacia ma anche la minore tossicità del dronedarone 400mg bid rispetto allamiodarone 600 mg qd prima e 200 mg qd poi (7). Il profilo di sicurezza del dronedarone è vantaggioso per i pazienti senza cardiopatia e con cardiopatia emodinamicamente stabile. Lo studio ANDROMEDA è stato infatti interrotto precocemente per un incremento della mortalità nei pazienti con insufficienza cardiaca moderata-severa per peggioramento della funzionalità cardiaca (8).
Controllo delle patologie concomitanti
Lo scopo è di prevenire o ritardare il rimodellamento miocardico associato allipertensione, insufficienza cardiaca, infiammazione in modo da limitare lo sviluppo di una FA (prevenzione primaria) o la progressione ad una forma permanente (prevenzione secondaria).
Nella prevenzione primaria, ACE inibitori o sartani dovrebbero essere considerati nei pazienti con scompenso cardiaco o ridotta razione di eiezione, con ipertensione e cardiopatia ipertrofica; le statine dopo un intervento di by-pass o sostituzione valvolare.
Nella prevenzione secondaria, andrebbero considerati ACE inibitori e sartani.
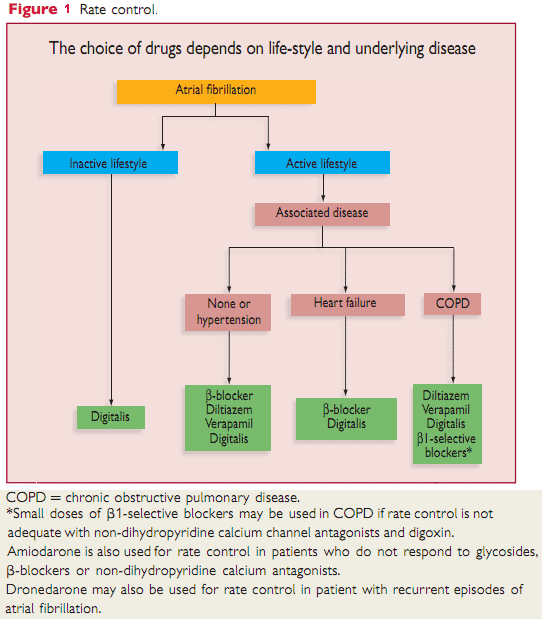
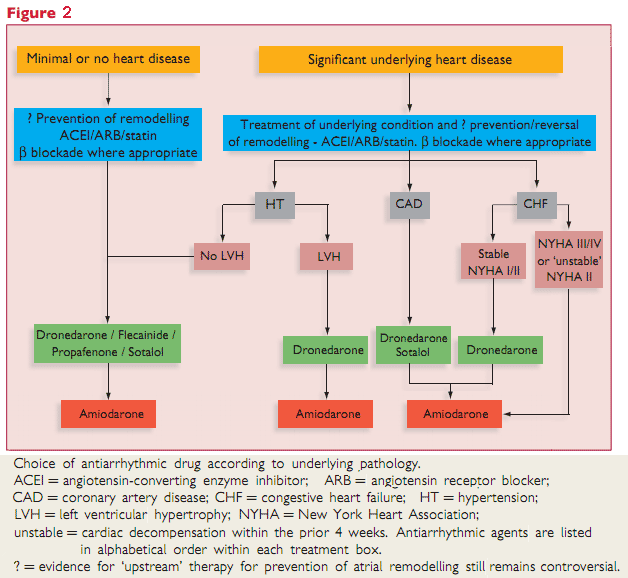
Raccomandazioni in specifiche popolazioni
Scompenso cardiaco
Farmaci di prima scelta per il controllo della frequenza cardiaca sono i beta-bloccanti e lamiodarone in presenza di instabilità emodinamica; in caso di inefficacia si può aggiungere la digitale ai beta-bloccanti. Le strategie di controllo del ritmo non si sono dimostrate superiori al controllo della frequenza cardiaca: si raccomanda la cardioversione elettrica in pazienti con ischemia subentrante, marcata ipotensione, congestione polmonare.
Atleti
Nelle forme parossistiche, si consiglia lutilizzo di propafenone o flecainide per la cardioversione (approccio “pill-in-the-pocket) e la sospensione dellattività sportiva per la durata dellaritmia e fino a che non trascorrano 1-2 emivite dei farmaci utilizzati. Lablazione con catetere può essere considerata negli altri casi.
Valvulopatie Il management della FA segue le usuali raccomandazioni. Per quanto riguarda la terapia anticoagulante, in presenza di stenosi/insufficienza mitralica il range di INR rimane tra 2-3, in presenza di valvola meccanica si raccomanda di mantenere un INR almeno di 2.5 se la valvola è in posizione mitralica e di 2 se in posizione aortica.
Sindromi coronariche acute
La cardioversione elettrica è indicata nei pazienti emodinamicamente instabili e con ischemia refrattaria. Per il controllo della frequenza cardiaca, si raccomanda infusione di beta-bloccanti o calcio-antagonisiti non diidropiridinici per ridurre la richiesta miocardica di ossigeno mentre è preferibile utilizzare digossina o amiodarone nei pazienti con severa compromissione della funzionalità del ventricolo sinistro.
Anziani
Si raccomanda nei pazienti di età superiore ai 65 anni la valutazione del polso periferico e, in caso di irregolarità, lesecuzione di un ECG.
Gravidanza La procedura di cardioversione elettrica è sicura in ogni fase della gravidanza sia per il feto che per la madre e si consiglia per le forme emodinamicamente instabili e quando il rischio di nuovi episodi FA è alto. La terapia anticoagulante va effettuata utilizzando eparina a basso peso molecolare nel primo trimestre e nel mese prima del parto, antagonisti della vitamina K nel rimanente periodo.
Ipertiroidismo
Il primo passo è riportare il paziente ad uno stato di eutiroidismo. Per il controllo della frequenza cardiaca si raccomanda lutilizzo dei beta-bloccanti o, se controindicati, di calcio-antagonisti non diidropiridinici.
Bibliografia
- Kirchof P, Auricchio A, Bax J, Crijns H, Camm J, Diener HC, Goette A, Hindricks G, Hohnloser S, Kappenberger L, Kuck KH, Lip GY, Olsson B, Meinertz T, Priori S, Ravens U, Steinbeck G, Sverhage E, Tijssen J, Vincent A, Breithardt G. Outcome parameters for trials in atrial fibrillation: executive summary. Reccomendations from a consensus conference organized by the German Atrial Fibrillation Competence NETwork (AFNET) and the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J 2007; 28: 2803-2817.
- Gage BF, Waterman AD, Shannon W, Boechler M, Rich MW, Radford MJ. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 2001; 285: 2864-2870.
- Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJ. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Chest 2010; 137: 263-272.
- Connolly SJ, EzekowitzMD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A, Pogue J, Reilly PA, Themeles E, Varrone J, Wang S, Alings M, Xavier D, Zhu J, Diaz R, Lewis BS, Darius H, Diener HC, Joyner CD, Wallentin L. Dabigatran versus farfari in patients with atrial fibrillation. N Eng J Med 2009; 361: 1139-1151.
- AFFIRM Investigators. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2002; 347: 1825-1833.
- Van Gelder IC, Groenveld HF, Crijns HJ, Tuininga YS, Tijssen JG, Alings AM, Hillege HL, Bergsma-Kadijk JA, Cornel JH, Kamp O, Tukkie R, Bosker HA, Van Veldhuisen DJ, Ven den Berg MP. Lenient versus strict rate control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2010; 362: 1363-1373.
- Le Heuzey J, De Ferrari GM, Radzik D, Santini M, Zhu J, Davy JM. A short-term, randomized, double-blind, parallel-group study to evaluate the efficacy and safety of dronedarone versus amiodarone in patients with persistent atrial fibrillation: the DIONYSOS study. J Cardiovasc Electrophysiol 2010; 21: 597-605.
- Kober L, Torp-Pedersen C, McMurray JJ, Gotzsche O, Levy S, CriJns H, Amlie J, Carlsen J. increased mortality after dronedarone therapy for severe heart failure. N Engl J Med 2008; 358: 2678-2687.