Terapie Antinfiammatorie [TERAPIA ANTINFIAMMATORIA] Malattie osteoarticolari: terapie antinfiammatorie a confronto |  |
Il dolore rappresenta la principale causa di ricorso al medico e tra le cause più frequenti di dolore, specie nella popolazione adulta e geriatrica, vi è il dolore muscolo-scheletrico. Una vasta indagine canadese ha dimostrato che un quarto della popolazione viene visitata dal medico di medicina generale per questo tipo di dolore 1 e questo dato epidemiologico canadese trova una conferma italiana in uno studio eseguito nelle Marche su 3664 pazienti selezionati in maniera casuale nelle liste di 16 medici di famiglia 2 che ha documentato una prevalenza di patologie muscolo-scheletriche nel 27,6% della popolazione studiata.
La terapia antinfiammatoria trova naturale indicazione nelle patologie infiammatorie sia acute che croniche e nella gestione delle patologie degenerative (artrosi). In alcune artriti (quali ad esempio l’artrite gottosa e la spondilite anchilosante) gli antinfiammatori rappresentano la terapia di prima scelta mentre in altre (ad esempio l’artrite reumatoide) sono un valido aiuto nella gestione della sintomatologia dolorosa.
L’artrosi rappresenta senza dubbio la patologia osteoarticolare più diffusa. Gli antinfiammatori agiscono controllando il dolore e la flogosi legati alla malattia. Il paracetamolo, molecola indicata come prima scelta dalle linee guida per il trattamento dell’artrosi sviluppate dalle principali società scientifiche internazionali, presenta invece solo un’azione antidolorifica che nel lungo termine risulta essere però significativamente inferiore rispetto a quella ottenibile con gli antinfiammatori. Il problema degli antinfiammatori, specie nell’uso cronico tipico della reumatologia, è infatti il profilo di sicurezza. Tutto ciò è complicato dal fatto che molti FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) vengono venduti come prodotti da banco con conseguente frequente uso in automedicazione e quindi senza nessun tipo di controllo da parte della classe medica.
Antinfiammatori e apparato gastrointestinale
Tra gli effetti collaterali dei farmaci antinfiammatori la gastropatia è certamente il più frequente. Le dimensioni del problema nella popolazione geriatrica, quella certamente più a rischio, sono state recentemente analizzate da uno studio clinico che ha preso in considerazione le ospedalizzazioni per patologie gastrointestinali. Lo studio ha dimostrato non solo la gastrolesività dei FANS ma anche l’importante responsabilità del paracetamolo nel potenziare questa tossicità 3 sollevando forti dubbi sul razionale della combinazione tra queste due classi di farmaci. L’azione degli antinfiammatori si realizza mediante l’inibizione delle cicloossigenasi e la conseguente riduzione delle prostaglandine. I FANS tradizionali sono inibitori non selettivi, in quanto agiscono su entrambe le isoforme dell’enzima, la cicloossigenasi 1 (COX-1) e la cicloossigenasi 2 (COX-2). La tossicità gastrointestinale è dovuta principalmente all’inibizione della COX-1: l’isoforma costitutiva coinvolta nella biosintesi di prostanoidi citoprotettivi per la mucosa gastrica e del trombossano A2 (TXA2) pro-aggregante le piastrine. Allo scopo di ridurre questo problema dei FANS sono stati pertanto sviluppati degli inibitori selettivi della cicloossigenasi (COX)-2, chiamati coxib, che vanno ad agire solo sulla isoforma inducibile tipica dell’infiammazione. La minore tossicità gastroduodenale dei coxib è stata documentata da una revisione della Cochrane Collaboration 4 che ha riconosciuto che con questi farmaci si realizza un numero significativamente inferiore di ulcere gastroduodenali e di relative complicazioni clinicamente importanti, nonché un minor numero di sospensioni del trattamento dovute a sintomi gastrointestinali rispetto ai FANS tradizionali. L’utilizzo dei coxib si associa a un rischio di lesioni gastroduodenali che è sovrapponibile a quella ottenibile associando a un FANS tradizionale un inibitore di pompa protonica (PPI) 5 e questo deve essere considerato anche nel momento in cui si valutano i costi della terapia.
Coxib: efficacia antinfiammatoria e sicurezza
Le principali indicazioni all’uso degli antinfiammatori sono situazioni cliniche caratterizzate da sintomatologia dolorosa più o meno intensa e in questi casi per il paziente un’adeguata gestione del dolore rappresenta l’obiettivo principale. Quando si valuta la terapia antinfiammatoria si rischia invece il più delle volte di concentrarsi più sui problemi di “sicurezza” che su quelli di “efficacia”. La novità introdotta con i coxib è legata al 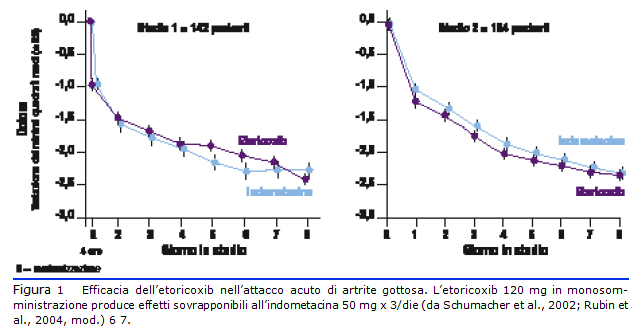 fatto che il miglior profilo di sicurezza gastrointestinale non si realizza a spese dell’efficacia antinfiammatoria e antidolorifica.
fatto che il miglior profilo di sicurezza gastrointestinale non si realizza a spese dell’efficacia antinfiammatoria e antidolorifica.
L’etoricoxib, in particolare, si è dimostrato nelle varie patologie reu-matologiche per lo meno equivalente ai FANS competitori e non solo nell’artrosi ma anche in modelli di dolore muscolo-scheletrico molto più severi e complessi 6 7. In questo studio randomizzato e controllato, infatti, etoricoxib 120 mg (in monosomministrazione) per 8 giorni di terapia, si è dimostrato efficace quanto una terapia di ugual durata con indometacina (50 mg assunti x 3/die) nel risolvere il quadro clinico dell’attacco acuto di artrite gottosa che rap-presenta uno dei modelli di dolore acuto muscolo-scheletrico più severi (Fig. 1).
Risultati ugualmente positivi si sono ottenuti anche in pazienti affetti da artrite reumatoide dove l’etoricoxib (90 mg/die) è risultato per lo meno sovrapponibile al naprossene (500 mg x 2/die) 8.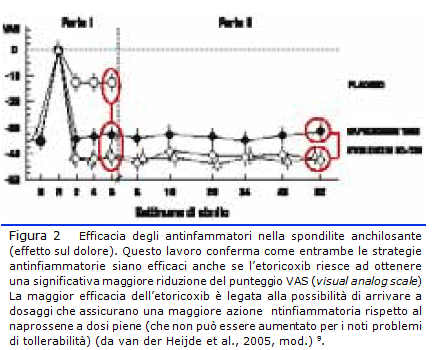 Particolarmente interessante è l’esperienza in pazienti con spondilite anchilosante dove l’etoricoxib (90-120 mg) ha prodotto un significativo maggior miglioramento miglioramento clinico sia rispetto al placebo dopo 6 settimane che, soprattutto, rispetto al naprossene 500 mg/ x 2/ die a 52 settimane (Fig. 2) 9.
Particolarmente interessante è l’esperienza in pazienti con spondilite anchilosante dove l’etoricoxib (90-120 mg) ha prodotto un significativo maggior miglioramento miglioramento clinico sia rispetto al placebo dopo 6 settimane che, soprattutto, rispetto al naprossene 500 mg/ x 2/ die a 52 settimane (Fig. 2) 9.
Questa superiore efficacia ha assicurato una maggior persistenza in trattamento ed una significativa minor percentuale di drop-out per inefficacia. Diverse sono le considerazioni che possiamo trarre dai vari studi disponibili su antinfiammatori e dolore muscolo-scheletrico:
-
emerge sempre più chiaramente come il confronto tra terapie farmacologiche differenti per quanto riguarda l’efficacia, la tollerabilità e i costi debba essere eseguito considerando sempre le diverse molecole a dosaggi equivalenti in termini di effetto antinfiammatorio. Molto spesso, invece, negli studi di confronto la scelta del dosaggio appare “condizionato” dai risultati che si vogliono ottenere in termini di maggior efficacia o maggiore tollerabilità. Una recente pubblicazione ha fornito una interessante tabella di equivalenza derivata dagli studi sulla spondilite anchilosante (Tab. I) 10 da cui emerge chiaramente che per avere un effetto sovrapponibile a 150 mg di diclofenac sono necessari per esempio 90 mg di etoricoxib, 400 mg di celecoxib, 2400 mg di ibuprofene, 1000 mg dinaprossene, 200 mg di ketoprofene ecc.;
-
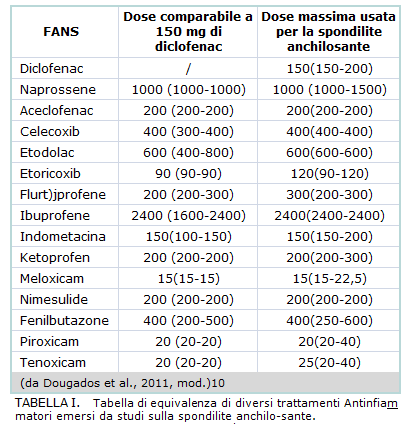 la maggior tollerabilità nel cronico dei coxib permette, con queste molecole in generale e con l’etoricoxib in particolare, di arrivare a dosaggi (120 mg/die) terapeutici che con altri FANS (ad esempio naprossene) non sarebbe possibile raggiungere senza esporsi ad esagerati rischi gastrointestinali;
la maggior tollerabilità nel cronico dei coxib permette, con queste molecole in generale e con l’etoricoxib in particolare, di arrivare a dosaggi (120 mg/die) terapeutici che con altri FANS (ad esempio naprossene) non sarebbe possibile raggiungere senza esporsi ad esagerati rischi gastrointestinali; -
una volta determinata la dose equivalente diventa importante sottolineare anche il numero di somministrazioni quotidiane necessarie. Ad esempio a fronte della monosomministrazione quotidiana dell’etoricoxib sono necessarie le 2-4 somministrazioni ogni giorno con gli altri antinfiammatori. Nel caso poi fosse indicata una gastroprotezione con i FANS tradizionali sarebbe necessaria un’ulteriore compressa quotidiana per ottenere lo stesso effetto antinfiammatorio e la stessa tollerabilità gastrica dei coxib che come abbiamo già detto sono per lo meno tollerati quanto FANS + PPI a livello di apparato digerente;
-
al momento non è disponibile alcun antinfiammatorio in grado di annullare il sintomo dolore. Dati particolarmente interessanti però emergono da una recente metanalisi di studi clinici controllati nell’artrosi 11. Innanzitutto è importante ricordare come sia sempre necessario utilizzare studi controllati (RCT, metanalisi di RCT) in quanto l’effetto placebo nella patologia articolare degenerativa ha un importante impatto clinico e l’efficacia dei farmaci antidolorifici/ antinfiammatori non può che essere rappresentata dalla differenza rispetto a un gruppo di controllo trattato con placebo.
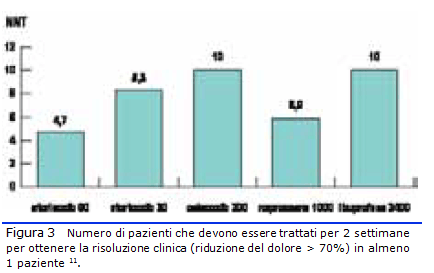
Un indicatore utile in questo caso può essere il NNT (Number Needed to Treat) che ci dice in pratica quanti pazienti dobbiamo trattare per averne uno che ottiene i benefici previsti. Se consideriamo trattamenti di 2 settimane (nella pratica clinica comune difficilmente si supera questa durata nella gestione di una riacutizzazione artrosica) e come effetto una riduzione del dolore ottimale (> 70%) emerge come l’etoricoxib 60 mg sia quello che presenta il NNT più basso (Fig. 3). Questo tipo di analisi può avere anche un impatto farmaco-economico dal momento che ci permette di vedere quanto costa una terapia antinfiammatoria anche in termini di efficacia: cioè quanto ci costa risolvere un episodio di riacutizzazione artrosica in un soggetto tenendo conto anche dei pazienti in cui il nostro trattamento produrrà solo un effetto sub-ottimale 12. In questi termini l’uso dei coxib e in particolare dell’etoricoxib appare essere ampiamente in linea con quelli dei FANS tradizionali e addirittura ai minimi se consideriamo anche una concomitante terapia gastroprotettiva (Tab. II).
Antinfiammatori e rischio CV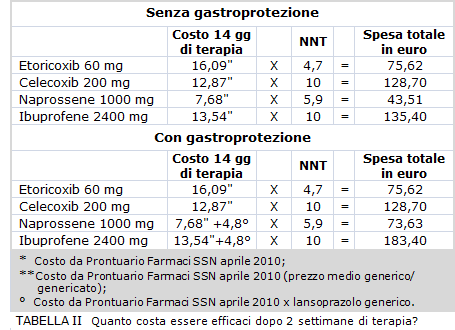
Nel corso dello sviluppo clinico degli inibitori selettivi della COX-2 èinaspettatamente emerso un incremento significativo del rischio cardiovascolare (CV) rispetto al placebo che è stato alla base nel settembre 2004 del ritiro dal commercio di rofecoxib/valdecoxib/ parecoxib. L’ipotesi patogenetica di gran lunga più accreditata per spiegare l’associazione tra uso cronico di coxib e rischio CV sarebbe la presenza di un effetto trombofilico legato allo sbilanciamento tra fattori pro trombotici ed antitrombotici. La prostaciclina ad azione vasodilatatrice e antiaggregante piastrinica (antitrombotica) viene prodotta dall’endotelio dei vasi principalmente attraverso l’attività della COX-2.
Il TXA2 rappresenta il maggior prodotto dell’attività della COX-1 piastrinica e ha un’azione opposta alla prostaciclina agendo come importante fattore pro-aggregante e vasocostrittore (protrom-botico). L’uso dei coxib, quindi, si accompagnerebbe a uno stato protrombotico legato al blocco della produzione di prostaciclina (COX-2-dipendente), che nel caso dei FANS tradizionali verrebbe in qualche modo controbilanciato dall’effetto antiaggregante piastrinico mediato dall’inibizione anche della COX-1 piastrinica. Va tuttavia ricordato che, mentre l’inibizione della COX-1 piastrinica assicurata dall’aspirina è quasi completa (> 95%), irreversibile e duratura, l’effetto dei FANS a questo livello è invece solo parziale e limitato nel tempo e pertanto privo di valore clinico. Per questo motivo, dopo il clamoroso ritiro dei coxib in precedenza citati, ha iniziato a farsi strada l’ipotesi che anche i FANS tradizionali, andando ad agire comunque sulla COX-2, potessero condividere con i coxib l’aumento del rischio CV. Questa ipotesi ha trovato sostegno nella pubblicazione di diversi studi osservazionali o caso controllo per poi essere confermata sperimentalmente dallo studio MEDAL 13. Questo trial clinico, che ha coinvolto oltre 35.000 pazienti, ha fornito la prova definitiva che il rischio CV trombotico nei pazienti trattati a lungo termine con un coxib (etoricoxib), è sovrapponibile a quello osservato nei pazienti trattati con FANS tradizionali (diclofenac).
Appare a questo punto chiaro che l’inibizione della COX-2 endoteliale, indipendentemente da come sia prodotta (coxib, FANS o addirittura aspirina se a dosi superiori a 650 mg/die) si associ a un aumento, assoluto o relativo, del rischio CV 14.
Molti si sono stupiti del fatto che, malgrado i FANS siano disponibili già dagli anni ’60, nessuno abbia in precedenza evidenziato l’associazione tra il loro utilizzo e il rischio CV. La spiegazione è semplice e dipende dal fatto che i FANS tradizionali sono stati registrati in epoche in cui i trial clinici coinvolgevano casistiche molto ridotte e avevano durata limitata spesso a poche settimane e quindi del tutto inadeguati a far emergere l’aumento del rischio CV che in termini assoluti rimane fondamentalmente limitato (intorno a 4 casi per mille pazienti trattati/ anno). Da questa osservazione deriva come conseguenza che i farmaci più vecchi in realtà non sono quelli più sicuri, semmai sono, al contrario, quelli meno attentamente studiati in particolare per quanto riguarda gli eventi rari. Una conferma in tal senso deriva dalla recentissima dimostrazione che la terapia con paracetamolo (disponibile fin dal 1940) si associa a un significativo aumento del rischio di ipertensione arteriosa del tutto sovrapponibile a quello che accompagna l’uso dei FANS e coxib. Questo emerge dai risultati dell’unico studio clinico controllato contro placebo eseguito con questo endpoint nei pazienti coronaropatici 15, dove gli autori concludono che si devono avere nei confronti del paracetamolo gli stessi accorgimenti e attenzioni riservati agli antinfiammatori specie nei pazienti con coronaropatia, quando al contrario per anni è stato consigliato alla classe medica l’uso del paracetamolo proprio in questo tipo di pazienti a rischio CV!
Interazione antinfiammatori ed ASA
L’interazione tra aspirinetta e FANS è un altro tema caldo e spesso sottovalutato. L’effetto negativo di alcuni FANS, quale ad esempio l’ibuprofene, è così evidente da essere quantificabile addirittura in termini di differente mortalità totale e CV, tra gruppo che assumeva solo aspirinetta e quello che assumeva aspirinetta e ibuprofene 16. Infatti nei pazienti che assumono ASA l’ibuprofene sopprime l’effetto antiaggregante piastrinico a causa della competizione a livello della COX-1 e questo verosimilmente vale, seppur in maniera variabile da mo
ecola a molecola, per tutti i FANS. Per questo motivo nei pazienti che assumono aspirina a basso dosaggio come antiaggregante piastrinico la scelta antinfiammatoria più razionale non può che essere il coxib che agendo selettivamente sulla COX-2 non interferisce con l’azione antiaggregante dell’ASA e quindi con la sua azione protettiva. Discusso è invece l’eventuale ruolo protettivo dell’ASA a basso dosaggio sull’aumento del rischio CV prodotto dagli antinfiammatori. Come abbiamo precedentemente spiegato, questo aumento del rischio CV è dovuto allo squilibrio nel rapporto tra eicosanoidi protrombotici e antitrombotici indotto dagli antinfiammatori. Questo squilibrio deriva essenzialmente dal blocco della produzione della prostaciclina endoteliale antitrombotica. Molti sostengono che l’associazione con ASA a basso dosaggio potrebbe compensare la situazione grazie alla sua capacità di ridurre la produzione del trombossano piastrinico protrombotico. Una recente analisi 17, eseguita misurando i metaboliti urinari degli eicosanoidi su pazienti che hanno partecipato ad uno studio clinico controllato sull’uso di antinfiammatori (naprossene e celecoxib) nella prevenzione dell’Alzheimer, ha evidenziato come nei pazienti incorsi in eventi CV ci sia realmente uno squilibrio relativo a favore dei fattori protrombotici proprio per la riduzione della prostaciclina. Tuttavia nello stesso studio è emerso come nei pazienti che assumevano ASA come antiaggregante il rapporto si riducesse in maniera protettiva solo nei pazienti che assumevano placebo e non in quelli che erano in trattamento con uno dei due antinfiammatori. In pratica, almeno apparentemente, l’azione positiva sul trombossano dell’aspirina non sembrerebbe in grado di compensare lo squilibrio prodotto da parte dei FANS e coxib mediante il blocco della produzione della prostaciclina endoteliale. In conclusione, i coxib rappresentano una valida opzione terapeutica per il trattamento dei pazienti con patologie osteoarticolari. La loro efficacia si associa a un profilo di sicurezza CV sovrapponibile a quello dei FANS tradizionali, ma significativamente superiore per quanto riguarda il rischio gastrointestinale e per la mancata interferenza con l’azione antiaggregante dell’acido acetilsalicilico.
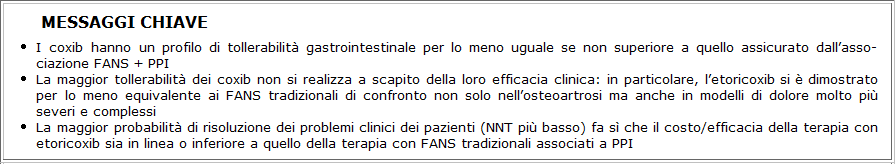
Bibliografia
-
Power JD, Perruccio AV, Desmeules M, et al. Ambulatory physician care for musculoskeletal disorders in Canada. J Rheumatol 2006;33:133-9.
-
Salaffi F, De Angelis R, Stancati A. Health-related quality of life in multiple musculoskeletal conditions: a crosssectional population based epidemiological study. II. The MAPPING study. Clin Exp Rheumatol 2005;23:829-39.
-
Rahme E, Barkun A, Nedjar H, et al. Hospitalizations for upper and lower GI events associated with traditional NSAIDs and acetaminophen among the elderly in Quebec, Canada. Am J Gastroenterol 2008;103:872-82.
-
Rostom A, Muir K, Dubé C, et al. Gastrointestinal safety of cyclooxygenase-2 inhibitors: a Cochrane Collaboration systematic review. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5:818-28.
-
Chan FK, Hung LC, Suen BY, et al. Celecoxib versus diclofenac and omeprazole in reducing the risk of recurrent ulcer bleeding in patients with arthritis. N Engl J Med 2002;347:2104-10.
-
Schumacher HR Jr, Boice JA, Daikh DI. Randomised double blind trial of etoricoxib and indometacin in treatment of acute gouty arthritis. BMJ 2002;324:1488-92.
-
Rubin BR, Burton R, Navarra S. Efficacy and safety profile of treatment with etoricoxib 120 mg once daily compared with indomethacin 50 mg three times daily in acute gout: a randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2004;50:598-606.
-
Matsumoto AK, Melian A, Mandel DR, et al. A randomized, controlled, clinical trial of etoricoxib in the treatment of rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2002;29:1623-30.
-
van der Heijde D, Baraf HS, Ramos-Remus C, et al. Evaluation of the efficacy of etoricoxib in ankylosing spondylitis: results of a fiftytwo-week, randomized, controlled study. Arthritis Rheum 2005;52:1205-15.
-
Dougados M, Simon P, Braun J, et al. ASAS recommendations for collecting, analysing and reporting NSAID intake in clinical trials/epidemiological studies in axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2011;70:249-51.
-
Moore RA, Moore OA, Derry S, et al. Responder analysis for pain relief and numbers needed to treat in a metaanalysis of etoricoxib osteoarthritis trials: bridging a gap between clinical trials and clinical practice. Ann Rheum Dis 2010;69:374-9.
-
Gatti D, Viapiana O, Colombo G, et al. Quanto costa una terapia con antinfiammatori? Reumatismo 2010 (in press).
-
Cannon CP, Curtis SP, FitzGerald GA, et al. MEDAL Steering Committee: Cardiovascular outcomes with etoricoxib and diclofenac in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis in the Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term (MEDAL) programme: a randomised comparison. Lancet 2006;368:1771-81.
-
Patrono C, Baigent C. Low-dose aspirin, coxibs, and other NSAIDS: a clinical mosaic emerges. Mol Interv 2009;9:31-9.
-
Sudano I, Flammer AJ, Périat D, et al. Acetaminophen increases blood pressure in patients with coronary artery disease. Circulation 2010;122:1789-96.
-
MacDonald TM, Wei L. Effect of ibuprofen on cardioprotective effect of aspirin. Lancet 2003;361:573-4.
-
Montine TJ, Sonnen JA, Milne G, et al. Elevated ratio of urinary metabolites of thromboxane and prostacyclin is associated with adverse cardiovascular events in ADAPT. PLoS One 2010;5:e9340.



